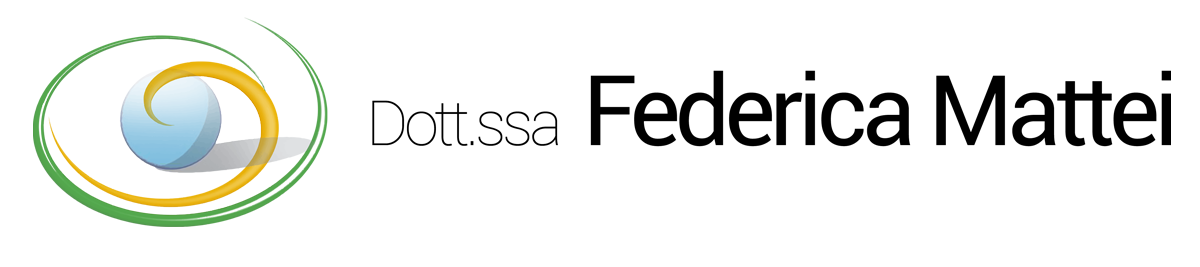- Adolescenza: Comportamenti a Rischio
- Lutto, Perdita e Separazione
- Problemi Scolastici di Inserimento e Dispersione Scolastica
- Genitori-Figli: Comunicazione e Relazione
- Ansia generalizzata in infanzia e adolescenza
- Bullismo, disturbi condotta e comportamento
- Deficit di attenzione/iperattività (ADHD)
- Evacuazione: enuresi ed encopresi
- Fobie nei bambini e negli adolescenti
- Linguaggio e Comunicazione
- Disturbi da Tic
- Autismo
- Ritardo mentale
Adolescenza: Comportamenti a Rischio
L’adolescenza è una fase evolutiva molto difficile e complessa, in cui si verificano rapide modificazioni fisiche, sessuali, psicologiche, cognitive e sociali, alle quali l’adolescente deve adattarsi.
Lo sviluppo dell’identità si realizza attraverso la ricerca di nuovi valori e nuove identificazioni al di fuori della famiglia; in questo periodo il gruppo dei coetanei rappresenta un’istanza autorevole, che impone un sistema di norme.
L’accettazione nel gruppo dei pari passa attraverso regole rigide ed influenza in modo determinante il comportamento dei singoli e l’adozione o il rifiuto delle norme di sicurezza.
Lo sviluppo dell’identità si realizza anche esplorando i limiti fisici e psichici e le proprie possibilità; capita così che spesso, per mettere alla prova se stessi, i giovani adottano comportamenti pericolosi quali: il consumo di alcolici, uso e abuso di sostanze (droghe di vario tipo), comportamenti devianti, attività sessuale promiscua o non sicura, stile di guida spericolato e disattento, soprattutto se attuato nell’ambito di sfide fra pari o in gruppo.
Bisogna comunque sottolineare come i comportamenti a rischio assolvono spesso, a questa età, funzioni ben precise, sebbene siano dannosi dal punto di vista fisico, psichico e sociale, sembrano fornire all’adolescente una via di uscita alle insicurezze e alle incertezze sperimentate in questa fase della vita. Per quanto pericolosi per sé e per gli altri, essi vengono ricercati poiché permettono di raggiungere alcuni obiettivi che sono molto importanti per gli adolescenti quali ad esempio: l’affermazione della propria identità e la costruzione di relazioni sociali e affettive.
Secondo una linea di sviluppo auspicabile i ragazzi riescono a raggiungere questi scopi attraverso strade adattive, senza mettere in pericolo il loro benessere fisico, psicologico e sociale; risultano quindi in grado di gestire le ansie e i problemi della discontinuità senza distruggere il loro senso di unità interiore. Molti adolescenti, invece, non trovano altro modo per realizzare questi obiettivi se non attraverso i comportamenti a rischio.
Per affermare il loro sentirsi “adulti” ed autonomi, essi ricorrono allora ad attività quali ad esempio condotte sessuali a rischio (non utilizzo di adeguata profilassi, promiscuità sessuale) od opposizione alle norme di riferimento (molte fra le condotte a rischio “aiutano” l’adolescente a sentirsi adulto facendo ciò che fanno i “grandi”). Inoltre alcuni comportamenti definiti “fase-specifici”, permettono anche l’identificazione con il gruppo dei pari: fumare sigarette, bere, avere rapporti sessuali come fanno i propri amici permette di sentirsi come loro e facilita l’accettazione nel gruppo.
La particolare frequenza con cui certi adolescenti vanno incontro ad incidenti, ad esempio, non è casuale, ma è piuttosto la testimonianza di una particolare condizione psicologica.
L’incidente sembra assume il significato di una particolare forma di agito che rende manifesta la difficoltà dell’adolescente di vivere ed elaborare a livello psichico le proprie problematiche.
L’incidente precoce, e con molta probabilità ripetitivo può essere il sintomo di difficoltà personali e assumere il valore di una modalità di funzionamento della persona.
Le profonde trasformazioni psicofisiche, connesse ai processi maturativi della pubertà e dell’adolescenza, pongono l’attenzione sulla dimensione corporea, che in questa fase evolutiva diventa uno degli ambiti privilegiati di definizione della propria identità personale nelle sue diverse componenti: sessuale, sociale, relazionale, professionale.
La conoscenza del proprio corpo passa attraverso l’esperienza dei suoi limiti, fin dall’infanzia, infatti si possono individuare situazioni, ludiche e non, la cui caratteristica specifica è quella di verificare l’esperienza dei propri limiti psicofisici; la prova di coraggio e il superamento della paura sono esperienze fondamentali della crescita che vedono il corpo come protagonista.
Abbiamo quindi visto come i comportamenti definiti “a rischio” siano frequenti e, soprattutto, di difficile gestione e comprensione soprattutto da parte della famiglia.
Lutto, Perdita e Separazione
Nel caso della separazione coniugale la situazione del bambino è molto critica, soprattutto se non è preparato e non ne comprende i termini. Può provare la sensazione di non poter più ricevere appoggio dai genitori e di essere abbandonato a se stesso e la separazione coniugale può essere per lui fonte di sensi di perdita, di inadeguatezza a gestire la situazione, ma anche di sentimenti di delusione, rabbia e colpa.
Il genitore che non vive più all’interno della famiglia non è spesso in grado di assicurargli sufficiente appoggio, in quanto la non quotidianità porta ad un allentamento del loro rapporto reciproco, ma anche il genitore che vive con il bambino può essere poco disponibile nei suoi confronti dedicando le sue energie alla risoluzione della sua crisi personale.
Frequentemente il bambino si trova, quindi, di fronte alla non disponibilità dei genitori ad aiutarlo ad affrontare le sue difficoltà, essendo entrambi impegnati a risolvere i loro conflitti.
Tutte queste problematiche oltre a ripercuotersi sullo sviluppo del bambino hanno una forte influenza anche sulla sua socializzazione: il mancato sviluppo di capacità autonome di interpretazione e di gestione degli eventi, il forte coinvolgimento nelle problematiche della famiglia e le difficoltà di svincolo da essa, oltre a diminuire la sua attenzione e il suo interesse per le relazioni sociali, potrebbero renderlo anche incompetente in esse.
Sono certo problematiche che i genitori recepiscono, ma avendo un carico notevole di responsabilità dovute anche al tentativo di risoluzione di eventuali conflitti coniugali, non sono a volte in grado di mettere in atto comportamenti adeguati e funzionali a rasserenare il bambino.
La separazione può essere anche molto dolorosa ma come ogni evento ha necessità di essere accettata; potrebbe essere dannoso per il minore trovarsi in una situazione di conflitto coniugale in cui egli è oggetto di rivendicazione; il bambino o l’adolescente può restare invischiato in dinamiche complesse ovvero non essere in grado trovare le risorse personali e/o sociali necessarie per la loro gestione.
In caso di lutto l’indicazione principale è la seguente “parlarne è meglio che evitare di farlo”.
Dire la “verità” e trovare gli strumenti per affrontarla ovvero parlare di ciò che è accaduto, aiuta il bambino ad organizzarsi per far fronte alla situazione. Evitare di parlarne può far emergere nel minore fantasie non funzionali. Le fantasie più frequenti possono essere quelle relative al senso di colpa e alla paura che la stessa disgrazia possa accadere a sé o all’altro genitore o ad un familiare.
Consentire l’espressione delle emozioni, riconoscerle e farle riconoscere è l’aiuto concreto che si può dare al bambino colpito da lutto. Rassicurandolo che il dolore, la nostalgia, la rabbia sono emozioni possibili, naturali rispetto all’evento. Evitare il dolore non è la strategia migliore, in quando il dolore è un’emozione e come tale va vissuta.
Ciascuno reagisce in modo diverso; alcuni ne parlano e fanno tante domande, altri si chiudono e si isolano. In ogni caso è importante rispettare la reazione che il bambino manifesta, segnalando la possibilità di parlare della morte e soprattutto la possibilità che questo spazio rimanga aperto al bisogno, nei tempi e nei luoghi che verranno scelti dal bambino.
In qualunque modo si realizzi, l’importante è che ciò avvenga. Un altro modo per rendere più tollerabile il lutto è creare nel bambino un pensiero sostenibile.
In ogni caso lo psicologo può intervenire attraverso un attento processo di consulenza e sostegno psicologico rivolto sia alla famiglia che al minore.
Problemi Scolastici di Inserimento e Dispersione Scolastica
L’inserimento nell’ambiente scolastico richiede al bambino di confrontarsi con attività cognitive sempre più complesse, di adattarsi ad un nuovo ambiente, a nuove figure adulte di riferimento, ad un insieme di nuove norme e regolamenti; anche le interazione con il gruppo dei coetanei diventano più elaborate ed impegnative.
Si possono, così, riscontrare delle differenze nella facilità o difficoltà di inserimento e adattamento del bambino all’ambiente e alla vita scolastica.
Ci sono bambini che non mostrano nessuna particolare difficoltà sin dall’inizio, altri che devono superare una fase iniziale di disagio ed incertezza, altri, invece, che non sono in grado affrontare e sostenere i compiti che la scuola pone sia sul piano cognitivo che sul piano sociale.
Il bambino che manifesta maggiori difficoltà può presentare diversi sintomi quali:
pigrizia nell’alzarsi dal letto, vestirsi, fare colazione, mal di pancia, nausea, vomito, inappetenza, mal di testa
forti resistenze e proteste nel momento di varcare il cancello della scuola, in classe piange e chiede di tornare a casa.
Nei casi più difficili si può innescare un intenso rifiuto per la scuola, situazione caratterizzata da una forte ansia e disagio che manifesta il bambino nel momento di andare a scuola.
Spesso i disturbi spariscono nel fine settimana o durante le vacanze.
Il rifiuto per la scuola, alcune volte, si manifesta dopo un primo periodo di normale inserimento, quando il bambino inizia a rendersi conto della realtà della scuola, degli impegni che prevede, del dover stare lontano da casa per un certo periodo di tempo durante la giornata.
Infatti, i fattori in grado scatenare questo disturbo, possono essere anche l’immaturità affettiva e l’ansia di separazione.
Le motivazioni che sono alla base del rifiuto della scuola sono molteplici, oltre a quelle già riportate, vanno presi in considerazione i fattori legati all’ansia di imparare, alle difficoltà di approccio con lo studio che comportano la sperimentazione del fallimento, e l’incapacità del bambino a sopportare le frustrazioni, o tollerare gli insuccessi, ciò può sviluppare un senso di inadeguatezza, il pensiero di non corrispondere alle aspettative dei genitori e/o degli insegnanti.
Un’altra difficoltà è data dal dover stare per molto seduti al banco, per cui alcuni bambini manifestano sintomi di irrequietezza, non riescono a stare fermi sulla sedia si alzano in continuazione; anche i rapporti con i coetanei possono incidere, molti bambini sperimentano nella scuola difficoltà a relazionarsi con gli altri.
Lo scarso rendimento scolastico non può essere interpretato, principalmente, in funzione dell’intelligenza e della buona volontà, ma i comportamenti inadeguati, il disimpegno, i rifiuti sono spesso l’espressione di disagi affettivi e relazionali.
E’ necessario distinguere l’insuccesso scolastico dalla flessione nel rendimento, in quest’ultimo caso è presente un periodo di scolarità soddisfacente prima che appaiano i segni di una flessione.
Nella maggior parte dei casi, la flessione del rendimento può essere interpretata come una risposta a difficoltà di varia origine, questa può dipendere, infatti da varie cause, spesso concomitanti fra loro, che vanno ricercate nelle caratteristiche individuali del soggetto, nell’ambiente scolastico e in quello familiare.
Con il termine dispersione scolastica, invece, si intende di solito una serie di eventi che determinano interruzioni e rallentamenti nell’iter scolastico
E’ un fenomeno complesso, i cui elementi principali sono la mancata iscrizione, la ripetenza, il ritardo, l’abbandono, l’insuccesso scolastico.
La dispersione scolastica non si manifesta ed identifica unicamente con l’abbandono.
Le cause della dispersione scolastica non sono solo quelle attribuibili all’ambiente socio-economico e al disagio personale in moltissimi casi il distacco dalla scuola, infatti non avviene con l’abbandono, ma con la disaffezione, il disinteresse, la demotivazione, noia, mancanza di esperienze positive. Tali manifestazioni si basano spesso su difficoltà d’apprendimento e su una carriera scolastica vissuta più come obbligo esterno (familiare, sociale), che come una motivazione interna bisogno di affermazione, crescita, acquisizione di conoscenze, capacità per realizzarsi come persona.
Per questo motivo è importante considerare l’alunno nella sua globalità, tenendo conto del livello di maturità raggiunto, della relazione fra dimensione emotiva e cognitiva, delle risorse e dei limiti personali, del contesto relazionale in cui è inserito.
Genitori-Figli: Comunicazione e Relazione
Nella comunicazione familiare il dialogo, l’ascolto, l’attenzione sono gli elementi fondamentali per la crescita, lo sviluppo e la maturità dei figli.
Per instaurare una comunicazione efficace è importante partire da una dimensione di ascolto, prestando attenzione alle emozioni e alle opinioni che i figli possono esprimere.
E’ una modalità di comunicazione che va costruita quotidianamente, con pazienza e attenzione, cominciando dai primi scambi verbali e non verbali.
Quando i bambini sono piccoli è importante la funzione e la modalità della comunicazione – numero di scambi, varietà di segnali, ricchezza del linguaggio – per aiutarli a sviluppare il linguaggio, le competenze comunicative e l’intelligenza.
E’ fondamentale prendere seriamente quello che dice il bambino, che ha bisogno di essere ascoltato attentamente e non superficialmente.
L’essere sempre interrotto o criticato non gli permette di acquisire sicurezza nei suoi stessi pensieri e di sviluppare un buon livello di autostima, ma anche, dargli sempre ragione, lasciarlo parlare continuamente quando ha bisogno di essere contenuto, non gli permettere di sviluppare un proprio senso critico e la capacità di interpretare in modo obiettivo ed equilibrato un evento, una situazione, un argomento, ecc.
Il sostegno maggiore è dato dall’essere ascoltato fino in fondo, dal sentirsi compreso, appoggiato e contenuto e dalla possibilità di confrontarsi con l’adulto quando questi ha un’opinione diversa dalla sua.
Un aspetto fondamentale della comunicazione in famiglia è l’apertura al dialogo, infatti, è possibile uno sviluppo più armonico e sereno se c’è maggiore confidenza con i genitori e se si creano situazioni in cui è possibile per ognuno raccontare le proprie esperienze, quanto accade durante la giornata; i bambini, i ragazzi risultano emotivamente più equilibrati e socialmente maturi.
Un fase dello sviluppo che mette a dura prova la comunicazione fra genitori e figli è la fase adolescenziale. La conflittualità tra i bisogni di autonomia e di protezione dell’adolescente si esprimono all’interno della famiglia attraverso nuove e diverse forme di comunicazione sia verbali come silenzi,aggressività verbale, aumento dei conflitti, provocazioni, che non verbali come modo di vestire e di atteggiarsi, rapporto con il cibo, modalità di gestire gli spazi personali.
La fase dell’adolescenza caratterizzata da comportamenti che vanno dalla solitudine all’irrequietezza, dal rifiuto delle regole familiari (fino ad allora accettate) al rifiuto scolastico, dalle nuove richieste ed esigenze relative al desiderio di avere il motorino, di andare in discoteca, di non avere orari da rispettare, comporta delle irregolarità di condotta nel contesto familiare, che rischiano di compromettere in modo drastico la comunicazione all’interno della famiglia.
Le domande più frequenti che i genitori pongono agli psicologi c/o i nostri studi e centri di psicologia riguardo alle situazioni difficili che stanno vivendo sono:
- non riusciamo più a capire cosa vuole
- non riusciamo più a farci ascoltare
- cosa possiamo fare?
- come dobbiamo comportarci?
- come può aiutarci uno psicologo?
- si può risolvere il problema?
- dove abbiamo sbagliato perchè si rivolta così contro di noi?
- perchè si comporta così?
- è colpa nostra?
- perchè i miei figli sono così diversi tra loro quando ci siamo comportati con entrambi allo stesso modo?
- perchè è così svogliato, testardo, irascibile, taciturno?
- riusciremo di nuovo ad aver un rapporto sereno con lui/lei?
- la situazione si può aggravare?
- come sarà da adulto?
La comunicazione fra genitori e figli può, quindi, diventare difficile, i genitori possono sentirsi insicuri, poco informati, e i figli possono sentirsi incompresi, non ascoltati, e non trovare argomenti da condividere con i genitori.
Per i genitori è importante essere flessibili e cambiare le modalità comunicative adottate: mantenere il rapporto maturato con il figlio dall’infanzia rischia, infatti, di portare incomprensioni e continue ed esasperate richieste e provocazioni da parte del ragazzo, con il rischio di compromettere il dialogo e di rompere i rapporti.
Ansia generalizzata in infanzia e adolescenza
Questo disturbo è caratterizzato da sentimenti pervasivi di preoccupazione o ansia con evidenti sintomi fisici, difficili da controllare e che si manifestano per la maggior parte dei giorni per almeno sei mesi.
L’ansia generalizzata viene definito dal DSM-IV attraverso i seguenti criteri:
- ansia e preoccupazione eccessive riguardo ad innumerevoli eventi o attività della vita quotidiana (scuola, lavoro)
- difficoltà nel controllare la preoccupazioni
- sintomi quali: irrequietezza, tensione, facile affaticabilità, difficoltà a concentrarsi o vuoti di memoria, irritabilità, tensione muscolare, alterazioni del sonno (difficoltà ad addormantarsio a mantenere il sonno, sonno inquieto)
- l’ansia, la preoccupazione, o i sintomi fisici causano disagio clinicamente significativo o menomazione del funzionamento sociale, lavorativo o di altre aree importanti.
Nei bambini e negli adolescenti si manifesta principalmente con preoccupazioni relative agli impegni scolastici o alle prestazioni in generale, come gli impegni sportivi, o gli impegni sociali.
Può essere presente una tendenza al perfezionismo che genera uno stato di tensione, che può causare o un impegno eccessivo o in comportamenti di evitamento.
L’ansia si manifesta in varie forme, per esempio il bambino può presentare un atteggiamento di sfida, oppure essere molto irritabile o vivere momenti di chiusura e isolamento.
Il bambino ansioso vive costantemente un vago sentimento d’oppressione, associato ad un atteggiamento di attesa di un avvenimento vissuto come spiacevole ed imprevisto.
L’angoscia nei bambini trova espressione attraverso il corpo, sotto forma di sintomi somatici, come cefalea, vomito, dolori addominali o agli arti, oppure può diminuire la capacità di attenzione e manifestarsi distrazione e svogliatezza.
A partire dalla preadolescenza (11-12 anni) l’angoscia si esprime anche attraverso crisi di collera, atteggiamenti di continua richiesta, alterazioni comportamentali. In questa fase si riscontra una sintomatologia complessivamente più grave, con un maggior numero di sintomi, una maggiore compromissione del funzionamento sociale e personale ed una maggiore e più evidente sofferenza soggettiva.
Bullismo, disturbi condotta e comportamento
I disturbi della condotta Vengono definiti come modalità comportamentali abituali di violazione delle regole o dei diritti degli altri (regole naturalmente rapportate e relazionate all’età del soggetto) che tendono ad esprimersi nei vari ambiti sociali.
Il termine bullismo è utilizzato per indicare una particolare modalità di interazione tra bambini o ragazzi, per cui uno è protagonista di atti di aggressione e prevaricazione ed un altro si trova nel ruolo della vittima. Il bullismo può essere manifestato da un singolo individuo o da un gruppo, si tratta di un fenomeno sommerso, eppure molto diffuso.
E’ una forma di prepotenza, in cui un ragazzo sperimenta una condizione di profonda sofferenza, con senso di impotenza, di svalutazione della propria identità e di emarginazione dal gruppo, a causa del comportamento di prevaricazione di un compagno.
Gli atti di bullismo possono essere sia diretti, attacchi aperti nei confronti della vittima, che indiretti, isolamento sociale ed esclusione intenzionale dal gruppo. Nel primo caso si distinguono espressioni fisiche,come colpire con calci o pugni e appropriarsi o danneggiare oggetti altrui, ed espressioni verbali come prendere in giro, offendere, minacciare, umiliare.
Nel secondo caso il bambino preso di mira può essere escluso, ignorato o oggetto di chiacchere e pettegolezzi.
Il bullismno è differente dai dispetti e dalle risse che si manifestano tra i ragazzi, la differenza è data dal fatto che gli episodi si ripetono di continuo e generalmente i ragazzi coinvolti non sono capaci di difendersi. Chi assume il ruolo di “bullo” riesce ad esercitare il suo potere non solo perchè è più grande o più forte, ma perchè spesso gli altri si alleano con lui per proteggere se stessi.
Fare il bullo, in sintesi, significa dominare i più deboli con atteggiamenti aggressivi e prepotenti, sottoporre a continui maltrattamenti i compagni di classe o di giochi fisicamente e caratterialmente più indifesi.
E’ importante sottolineare il disagio enorme vissuto dalla vittima che si sente isolata ed esposta, e che ha spesso paura di riferire gli episodi in cui è stata coinvolta perchè teme delle ripercussioni. A lungo andare subisce una flessione molto forte anche il livello dell’autostima e della fiducia in se stessi che possono portare ad un considerevole disinvestimento dalla scuola, influendo sulla concentrazione e l’apprendimento. POssono manifestarsi anche sintomi quali mal di testa , mal di pancia, incubi o attacchi d’ansia, paura di andare a scuola. Le vittime rischiano quadri patologici con sintomatologie anche di tipo depressivo.
Deficit di attenzione/iperattività (ADHD)
Questo disturbo si manifesta con uma modalità di disattenzione e/o iperattività-impulsività che è più frequente e più grave di quanto si osservi in soggetti con un livello di sviluppo simile.
La classificazione del DSM-IV (APA. 1994) suddivide il disturbo in tre quadri clinici:
- tipo con disattenzione predominante, con prevalenza di sintomi di disattenzione
- tipo con iperattività/impulsività predominante, con prevalenza di sintomi di iperattività/impulsività
- tipo combinato, con prevalenza di entrambi i tipi di sintomi.
Criteri diagnostici
Criterio A (DSM-IV)
- per quanto riguarda il tipo con disattenzione predominante devono essere persistiti per almeno sei mesi sei dei seguenti sintomi:
- spesso non riesce a prestare attenzione ai particolare o commette errori di distrazione nei compiti scolastici, sul lavoro o in altre attività
- spesso ha difficoltà a mantenere l’attenzione sui compiti o sulle attività di gioco
- spesso non sembra ascoltare quando gli si parla direttamente
- spesso non segue le istruzioni e non porta a termine i compiti scolastici, le incombenze, o i doveri sul posto di lavoro (non a causa di comportamento oppositivo o di incapacità di capire le istruzioni)
- spesso a difficoltà ad organizzarsi nei compiti e nelle attività
- spesso evita, prova avversione, o è riluttante ad impegnarsi in compiti che richiedono sforzo mentale protratto (come compiti a scuola o a casa)
- spesso perde gli oggetti necessatri per i compiti o le attività (per esempio giocattoli, compiti di scuola, matite, libri o strumenti)
- spesso è facilmente distratto da stimoli esterni
- spesso è sbadato nelle attività quotidiane
- tipo con iperattività/impulsività predominante devono essere persistiti per almeno sei mesi sei dei seguenti sintomi:
iperattività
- spesso muove con irrequietezze mani o piedi e si dimena sulla sedia
- spesso lascia il proprio posto a sedere in classe o in altre situazioni in cui ci si aspetta che resti seduto
- spesso scorrazza e salta dovunque in modo eccessivo in situazioni in cui ciò è fuori luogo (negli adolescenti o negli adulti ciò può limitarsi a sentimenti soggettivi di irrequietezza)
- spesso ha difficoltà a giocare o a dedicarsi a divertimenti in modo tranquillo
- è spesso “sotto pressione” o agisce come se fosse “motorizzato”
- spesso parla troppo
- impulsività
- spesso “spara” le risposte prima che le domande siano state completate
- spesso ha difficoltà ad attendere il proprio turno
- spesso interrompe gli altri o è invadente nei loro confronti (per esempio si intromette nelle conversazioni o nei giochi)
- Criterio B. Alcuni dei sintomi di iperattività-impulsività o di disattenzione che causano compromissione erano presenti prima dei sette anni di età.
- Criterio C. Una certa menomazione a seguito dei sintomi è presente in due o più contesti (per esempio a scuola o al lavoro e a casa).
- Criterio D. Deve esservi una evidente compromissione clinicamente significativa del funzionamento sociale, scolastico o lavorativo (secondo la valutazione del clinico).
- Crierio E. un criterio di esclusione adottato è di considerare che i sintomi non si manifestino esclusivamente durante il decorso di un altro disturbo mentale e non risultano meglio attribuibili ad un altro disturbo mentale.
- enuresi notturna: è il sottotipo più comune, in cui la perdita di urine si ha solo durante il sonno notturno. Si manifesta principalmente durante il primo terzo della notte, solo occasionalmente l’emissione avviene durante il sonno REM, e può accadere che il bambino ricordi un sogno che comportava l’atto di urinare
- enuresi diurna: la perdita di urina si ha durante il giorno, è più comune nelle femmine che nei maschi, ed è rara dopo i nove anni. Si manifesta più frequentemente nel primo pomeriggio dei giorni di scuola e può esssere dovuta a difficoltà ad usare il bagno per ansia sociale o all’eccessivo coinvolgimento nelle attività.
- forma primaria: nella quale il bambino, oltre i quattro – cinque anni non ha mai raggiunto il controllo della continenza urinaria
- forma secondaria: nella quale il disturbo si sviluppa dopo aver raggiunto e mantenuto , per almeno 5-6 mesi, il controllo della continenza urinaria. L’enuresi secondaria si manifesta più frequentemente tra i cinque e gli otto anni.
- decorso primario: in cui il soggetto non ha mai raggiunto il controllo delle sfintere anale;
- decorso secondario: in cui il disturbo si manifesta dopo che per un certo periodo è stato raggiunto il normale controllo sfinterico.
- con costipazione e incontinenza da sovrariempimento: la fuoriscita delle feci è continua e avviene sia di giorno che durante la notte
- senza costipazione e incontinenza da sovrariempimento: le feci sono di consistenza normale il soggetto si sporca in modo intermittente. Le feci possono essere deposte in luoghi significativi.
- fobie specifiche, quali quelle scatenate da oggetti, animali o situazioni circoscritte e ben identificabili. Come negli adulti, si tratta di paure molto intense di oggetti specifici (animali; elementi dell’ambiente naturale come temporali, altezze, acqua; sangue o ferite) o situazioni specifiche (come il buio, i luoghi chiusi, i trasporti pubblici)
- fobie sociali, provocate dall’esposizione a certi tipi di situazioni o di prestazioni sociali, che spesso determinano condotte di evitamento: ne sono un esempio rifiutarsi di parlare in classe, di leggere davanti agli altri, avere gravi difficoltà a partecipare ad attività sociali o corali come feste, giochi, sport. Sono tipiche dell’adolescenza e insorgono, in genere, tra gli 11 e i 18 anni.
- disturbo dell’espressione del linguaggio
- disturbo misto dell’espressione e della ricezione del linguaggio
- disturbo della fonazione
- balbuzie
-
Disturbo dell’espressione del linguaggio
La caratteristica fondamentale del Disturbo della Espressione del Linguaggio, come viene definito nel DSM VI, è una significativa compromissione dello sviluppo del linguaggio espressivo che interferisce con i risultati scolastici e con la comunicazione sociale.
I sintomi variano a seconda della gravità e dell’età del bambino e riguardano:
- linguaggio limitato sul piano quantitativo (interventi rari e brevi)
- vocabolario limitato (lessico ridotto)
- difficoltà ad imparare parole nuove
- errori nell’utilizzare le parole e nel lessico
- frasi molto corte
- utilizzo di strutture grammaticali semplici
- utilizzo limitato di strutture grammaticali (per es. forme verbali)
- limitata varietà del tipo di frasi (per es. interrogative, imperative)
- omissioni di parti importanti della frase
- uso delle parole in un ordine insolito
- errori di coniugazione dei verbi
- difficoltà nel comporre frasi di lunghezza e di complessità adeguata al livello di sviluppo
- basso livello di sviluppo del linguaggio.
Di solito il funzionamento non linguistico e la capacità di comprensione del linguaggio sono nei limiti della norma.
Si distinguono due tipi di Disturbo della Espressione del Linguaggio:
- il tipo acquisito, dove la compromissione del linguaggio espressivo si manifesta dopo un periodo di sviluppo normale
- il tipo di sviluppo, dove vi è una compromissione del linguaggio espressivo che non è associata ad una lesione neurologica. I bambini affetti da questo tipo di disturbo spesso cominciano a parlare tardi e superano più lentamente del normale le varie tappe dello sviluppo della espressione del linguaggio.
Nei bambini piccoli il disturbo più comunemente associato al Disturbo della Espressione del Linguaggio è il Disturbo della Fonazione; in età scolare possono insorgere problemi scolastici e di apprendimento (dettato, copiatura, compitazione, lettura, ecc.).
-
Disturbo misto dell’espressione e della ricezione del linguaggio
La manifestazione principale di questo disturbo riguarda sia lo sviluppo del linguaggio espressivo che ricettivo, con una compromissione significativa dell’attività e dei risultati scolastici e delle comunicazione sociale.
Oltre ai sintomi presenti nel Disturbo della Espressione del Linguaggio si evidenziano sintomi relativi alla compromissione dello sviluppo della ricezione del linguaggio come la difficoltà nel comprendere parole, frasi o tipi particolari di parole (termini spaziali, frasi complesse come costruzioni ipotetiche).
Nei casi più gravi si può riscontrare l’incapacità di capire il vocabolario di base o frasi semplici e deficit nell’elaborazione uditiva ( discriminazione dei suoni, associazione di suoni e simboli, immagazzinamento, rievocazione e costruzioni di sequenze).
Il deficit di comprensione è la caratteristica principale che differenzia questo disturbo dal Disturbo della Espressione del Linguaggio e può variare in base alla gravità del disturbo e all’età del bambino.Le difficoltà della comprensione del linguaggio possono essere meno evidenti di quelle della produzione del linguaggio, si può riscontrare che il bambino:
- esegua indicazioni in modo scorretto
- risponda in modo inadeguato ad una domanda
- rispetti con difficoltà il proprio turno durante la conversazione
- non sia in grado di mantenere in modo coerente un argomento
- può sembrare che il bambino non senta o non presti attenzione quando gli si parla.
Si distinguono due tipi di Disturbo Misto della Espressione e della Ricezione:
- il tipo acquisito, nel quale la compromissione del linguaggio ricettivo ed espressivo si manifesta dopo un periodo di sviluppo normale
- il tipo di sviluppo, nel quale la compromissione del linguaggio e della ricezione non è associata con un danno neurologico. questo tipo è caratterizzato da un basso livello di sviluppo del linguaggio, in cui l’eloquio può iniziare con ritardo, e l’acquisizione delle varie tappe di sviluppo del linguaggio procedere molto lentamente.
-
Diturbo della Fonazione
L’atto della fonazione (articolazione del linguaggio e delle parole) risulta compromesso in modo significativo, la caratteristica fondamentale di questo disturbo, come viene definita nel DSM IV, è un’incapacità di usare i suoni dell’eloquio attesi in base al livello di sviluppo, e adeguati all’età e alla lingua del soggetto. Gli errori fondamentali riguardano la produzione, l’uso, la rappresentazione e l’organizzazione dei suoni; la sostituzione di un suono per un altro; omissioni di suoni.
il bambino che è in grado di produrre buone sequenze di parole e frasi e di comprendere bene quanto gli viene comunicato, può avere una immaturità relativa all’articolazione fonetica di uno o di alcuni suoni. I suoni che più frequentemente vengono articolati con difficoltà sono quelli che vengono acquisiti per ultimi nella sequenza evolutiva quali: l, r, s, z, gl, gn, c.
La blesità (difficoltà nell’articolazione delle sibilanti) è molto comune.
Il Disturbo di Fonazione può comprendere anche errori di selezione e di ordinazione dei suoni all’interno di sillabe e parole.
Gli errori di produzione fonetica (cioè di articolazione) comportano l’incapacità di formare i suoni dell’eloquio in modo corretto, per es. la difficoltà di decidere quali suoni del linguaggio determinano una differenza di significato. Si possono verificare casi in cui l’eloquio è comunque fluido e comprensibile e casi in cui l’eloquio è del tutto incomprensibile, compromettendo in modo significativo l’attività ed i risultati scolastici e la comunicazione sociale.
Le forme meno gravi del disturbo possono essere individuate solo quando il bambino inizia a frequentare la scuola ed ha difficoltà ad essere compreso da compagni e insegnanti. -
Balbuzie
La manifestazione principale della Balbuzie, come viene definita nel DSM IV, è un’anomalia del normale fluire e della cadenza dell’eloquio, inadeguati per l’età del soggetto, caratterizzata da frequenti:
- ripetizioni di suoni e sillabe
- prolungamento di suoni
- interiezioni
- interruzione di parole (pause all’interno di una parola)
- blocchi udibili o silenti
- circonlocuzioni (sostituzione di parole per evitare parole problematiche)
- parole emesse con eccessiva tensione fisica
- ripetizione di intere parole monosillabiche.
La balbuzie è un disturbo che generalmente insorge nell’età infantile, tipicamente nel periodo 2-6 anni.
Il balbuziente presenta maggiori difficoltà a controllare i processi di produzione della parola,e necessita di tempi più lunghi per coordinare ed organizzare l’atto verbale.
La gravità del disturbo varia nelle diverse situazione, spesso è più grave quando vi è una particolare pressione a comunicare, per es. fare una relazione a scuola, leggere in pubblico, spesso la Balbuzie è assente durante il canto o il colloquio con oggetti inanimati o con animali.
La Balbuzie può essere accompagnata da movimenti muscolari: tic, ammiccamenti, tremori delle labbra o del viso, scosse del capo.
In soggetti con Balbuzie possono insorgere anche il Disturbo della Fonazione e il Disturbo della Espressine del Linguaggio.
Il DSM-IV indica inoltre altri specifici criteri che devono essere contemporaneamente presenti per una diagnosi positiva di ADHD:
Evacuazione: enuresi ed encopresi
Enuresi
La manifestazione fondamentale dell’enuresi è una ripetuta emissione di urine, involontaria, occasionalmente può essere anche intenzionale, che avviene di solito durante il sonno, in bambini di almeno cinque anni di età, in assenza di lesioni all’apparato urinario e di condizioni mediche generali.
Come definito nel DSM IV il disturbo deve manifestarsi almeno due volte alla settimana per almeno tre mesi consecutivi, e determinare una compromissione significativa dell’area sociale, scolastica.
Si distinguono due sottotipi dell’enuresi:
L’enuresi può manifestarsi in due forme:
Encopresi
La manifestazione fondamentale dell’encopresi è la ripetuta evacuazione di feci, involontaria, più raramente volontaria, in luoghi inappropriati, per esempio nei vestiti, sul pavimento.
Come definito nel DSM IV l’evento deve verificarsi almeno una volta al mese per un periodo minimo di tre mesi in bambini di almeno quattro anni. Il disturbo non deve essere collegato agli effetti di farmaci o di una conduizione medica generale, se non attraverso un meccanismo che comporti costipazione.
Si distinguono due tipi di decorso:
L’encopresi può essere distinta in due sottotipi in base al quadro clinico:
Entrambi i disturbi (enuresi ed encopresi) sono più comuni, dal punto di vista della distribuzione tra i sessi, nei maschi.
Fobie nei bambini e negli adolescenti
Le paure sono episodi frequenti e comuni nella vita del bambino che accompagnano la sua crescita inscrivendosi nel suo normale sviluppo psichico.
Le paure cambiano in base all’età, nell’infanzia ci si trova di fronte a paure di tipo più irrazionale tipo: mostri, fantasmi, animali, con la crescita divengono sempre più complesse ed articolate, interessando più da vicino la sfera sociale e relazionale come ad esempio, la paura di apparire inadeguati.
I bambini rispetto alle loro paure possono avere atteggiamenti differenti: possono parlarne in modo esplicito, lamentarsi frequentemente e intensamente oppure cercare di mascherarle perchè si vergognano.
Quando una paura persiste e quando interferisce con le attività quotidiane , si parla di fobia, intesa come paura ingiustificata di un oggetto o di una situazione, il contatto con i quali determina una intensa reazione di angoscia.
La fobia ostacola la vita quotidiana ed è all’origine di reazioni eccessive e inadeguate, finalizzate ad evitare ogni contatto con l’oggetto o l’evento che crea ansia.
E’ possibile distinguere due grandi categorie di fobie:
La fobia si costituisce quando la paura supera le capacità adattive ed evolutive del bambino.
L’evitamento, l’ansia anticipatoria o il disagio nella situazione (situazioni) temuta interferiscono in modo significativo con la normale routine della persona, con il funzionamento lavorativo (o scolastico), o con le attività o le relazioni sociali, oppure è presente disagio marcato per il fatto di avere la fobia.
Linguaggio e Comunicazione
Per Disturbi del linguaggio e della Comunicazione si intendono:
Disturbi da Tic
I tic sono movimenti involontari rapidi, classificati in semplici se costituiti da movimenti brevi e stereotipati del volto, delle spalle e degli arti ed in complessi se costituiti da sequenze di movimenti, si tratta di movimenti improvvisi e senza finalità che tendono a ripetersi con un ritmo irregolare.
I tic motori semplici includono: ammiccamenti, torsioni del collo, alzate di spalle, smorfie del viso, colpi di tosse; mentre i tic vocali semplici includono: raschiarsi la gola, grugnire, tirare su con il naso, abuffare.
I tic motori complessi riguardano: movimenti mimici, saltare, toccare, battere i piedi,, odorare un oggetto; i tic vocali complessi riguardano, invece la ripetizione di parole o di frasi fuori dal contesto, nei casi più gravi, la coprolalia (uso di parole oscene) e l’ecolalia (ripetizione di suoni, parole o frasi udite per ultime).
Disturbo di Tourette
Le manifestazioni fondamentali del Disturbo di Tourette (o sindrome di Tourette), come viene definito nel DSM-IV, sono tic motori multipli e uno o più tic vocali, che si manifestano molte volte al giorno o in maniera intermittente per un periodo di più di un anno, durante il quale non c’è stato un periodo di più di 3 mesi consecutivi senza tic.
I tic riguardano il capo e altre parti del corpo, come tronco e arti superiori e inferiori.
I tic vocali includono parole, suoni, schiocchi della lingua, protrusione della lingua, grugniti, guaiti, tirare su con il naso, colpi di tosse, coprolalia.
Possono essere presenti tic motori complessi quali: toccare, accovacciarsi, fare passi indietro, fare piroette.
I sintomi più frequentemente associati al Disturbo di Tourette sono: ossessioni, compulsioni, iperattività, distraibilità e impulsività.
Le manifestazioni del Disturbo di tourette sono causa di un significativo malessere e disagio, che compromettono l’area scolastica, lavorativa e sociale.
Nei casi più gravi, i tic possono, infatti, interferire con le attività quotidiane, intralciandone il normale svolgimento, come leggere, scrivere, svolgere attività che richiedono particolare concentrazione.
Disturbo Cronico da Tic Motori o Vocali
La caratteristica principale di questo disturbo è la presenza o di tic motori o di tic vocali, ma non di entrambi, differentemente dal Disturbo di Tourette, in cui devono essere presenti sia i tic motori multipli che uno o più tic vocali.
Le altre caratteristiche principali sono le stesse del Disturbo di Tourette, tranne che per la gravità dei sintomi e la compromissione delle attività nell’ambito scolastico. lavorativo e sociale, che in questo caso sono molti minori.
Disturbo Transitorio da Tic
Si fa riferimento al Disturbo transitorio da Tic quando la presenza di tic motori singoli o multipli e/o di tic vocali si manifestano molte volte al giorno, quasi ogni giorno per almeno 4 settimane, ma per non più di 12 mesi consecutivi.
Le caratteristiche associate al Disturbo Transitorio da Tic sono le stesse del Disturbo di Tourette, ma come per il Disturbo Cronico da Tic Motori o Vocali la gravità dei sintomi e la compromissione delle attività della vita quotidiana è minore.