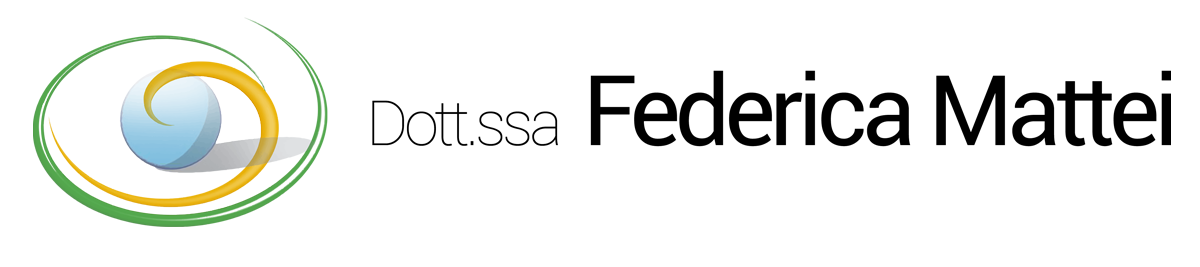Nella classificazione dei disturbi psicologici prendo spunto principalmente dal DSM (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali) dell’APA (American Psychiatric Association).
Si parla di disturbo psicologico per indicare una situazione di forte disagio individuale, contraddistinta da una sintomatologia di origine psicologica, la quale, poi, si diffonde ed interessa tutto l’organismo. Tale situazione solitamente investe in modo graduale e disfunzionale non solo la parte soggettiva, ma anche le altre fondamentali aree vitali dell’individuo, come ad esempio quella sociale, scolastica, interpersonale, familiare, lavorativa, sessuale, etc. Si generano specifici sintomi psicofisici che vanno a creare disagio e menomazione nelle molteplici sfere cruciali per il mantenimento del benessere e della salute sia psichica, che fisiologica.
I Disturbi Psicologici possono essere di tipo nevrotico o di tipo psicotico, a seconda del quadro sintomatologico presente nella persona.
- DISTURBI DELL’UMORE
- DISTURBI D’ANSIA
- DISTURBI PSICOSOMATICI (O SOMATOFORMI)
- DISTURBI SESSUALI
- DISTURBI DELL’ALIMENTAZIONE
- DISTURBI DEL SONNO
- DISTURBI PSICOTICI
- DISTURBI CORRELATI A SOSTANZE
- DISTURBI DEL CONTROLLO DEGLI IMPULSI
- DISTURBI DA STRESS (O DELL’ADATTAMENTO)
- DISTURBI DI PERSONALITÀ
DISTURBI DELL’UMORE
Si tratta di disturbi caratterizzati da un’alterazione dell’umore, cioè da un’alterazione del tono emotivo normalmente sperimentato in modo più o meno persistente lungo un continuum che va dalla tristezza alla felicità.
Si possono presentare periodi più o meno protratti di umore depresso/triste oppure di umore euforico/espansivo oppure periodi con un’alternanza più o meno rapida di entrambi. Nei casi più gravi i disturbi possono essere associati a manifestazioni psicotiche.
In caso di umore posizionato molto in basso, definibile anche come “umore depresso”, la persona presenta una forte tristezza giornaliera e l’incapacità di provare gli stessi positivi piaceri precedentemente percepiti nel fare le proprie attività e di percepire le ulteriori gioie provenienti dalle sue molteplici sfere vitali.
Infatti questa depressione (ed anche la fluttuazione umorale) determina un vero significativo disagio o menomazione nel normale funzionamento personale, sociale, lavorativo, scolastico, familiare, affettivo, etc., ovvero in tutte le varie aree della vita, collegate e funzionali al mantenimento del benessere psicofisico generale.
Chi soffre di depressione si sente continuamente a terra ed i suoi pensieri, le sue emozioni ed i suoi sentimenti sono quasi sempre fortemente negativi. In tal modo l’esistenza si trasforma in un dolore continuo che porta l’individuo all’incapacità di apprezzare qualsiasi cosa, situazione definita in psicologia “anedonia”. Dilagano allora tristezza, abbattimento, disperazione, scoraggiamento, sofferenza, così come chiusura in se stessi, pianto, rallentamento psicomotorio, calo delle prestazioni cognitive (es. memoria, pensiero, percezione, concentrazione), intontimento e confusione.
A livello neurologico è stata individuata e stabilita la connessione tra i livelli di funzionamento di certi neurotrasmettitori come Dopamina, Noradrenalina e Serotonina ed il tono umorale della persona.
L’umore è comunque direttamente e strettamente proporzionale anche alle dinamiche psicoemotive, cognitive e di atteggiamento, così come alle soggettive caratteristiche di personalità.
Certe volte l’alterazione umorale avviene in seguito ad eventi molto negativi della vita, i quali influenzano una mente già ipersensibile alle emozioni, scatenando così la personale costituzione neuropsicologica dell’individuo.
Il calo dell’umore quindi per essere patologico deve necessariamente esser distinto dai normali psicofisiologici momenti di sconforto o oscillazione; in tal modo esso diventa un vero e proprio disturbo quando perdura per settimane, mesi e/o anni e presenta una intensità ed una frequenza tali da rendere compromessa la normale vita della persona nelle sue diverse dimensioni (personale, sociale, lavorativa, relazionale, etc.).
Altri sintomi depressivi che rendono il problema non normale e passeggero, ma un vero e proprio disturbo sono: dismissione di qualsiasi interesse e rapporto sociale ed affettivo, risposte emotive inadeguate e/o eccessive, bassissima autostima, rallentamento e/o blocco psicocognitivo e fisico (es. blocco dei pensieri, sguardo fisso e attività mimico-gestuale e verbale lente), drastico aumento o diminuzione di fame e peso corporeo, sonno problematico (es. insonnia o ipersonnia), sintomi psicosomatici(es. dolori), allucinazioni, deliri, ideazioni di suicidio.
I Disturbi dell’Umore si possono distinguere in base alla loro polarità, riferita appunto al tono umorale della persona. Vi sono allora i Disturbi Bipolari, ovvero Disturbo Bipolare e Disturbo Ciclotimico, caratterizzati dalla fluttuazione dell’umore dall’alto al basso e, viceversa, i Disturbi Unipolari, cioè Disturbo Depressivo (Depressione) e Disturbo Distimico, contraddistinti solo e soltanto da un tono dell’umore intensamente depresso.
Le complicazioni più frequenti nel caso di un Disturbo dell’Umore può essere la comparsa diDisturbi dell’Alimentazione e/o di Disturbi d’Ansia (es. Disturbo di panico, Disturbo ossessivo-compulsivo).
Infine tali disturbi psicologici possono, se non affrontati, cronicizzare nel tempo, con il rischio di ampliarne le conseguenze pericolose come patologie fisiologiche, abuso e/odipendenza da alcol o da altre sostanze psicoattive e tentativi di suicidio.
DISTURBI D’ANSIA
Si tratta di disturbi caratterizzati ed accomunati dalla presenza di intensa e frequente ansia, principale loro sintomo psicologico che determina significativo disagio o menomazione nel normale funzionamento personale, sociale, lavorativo, scolastico, familiare, affettivo, etc.
L’ansia è una emozione di agitazione la quale, in piccola quantità, contribuisce ad attivare ed allertare l’individuo in situazioni di pericolo e/o nei casi in cui occorra un aumento di attenzione ed attivazione neuro-fisiologica, ad esempio prima di un esame o in caso di pericolo.
In tal caso essa tale reazione psicoemotiva non è da considerarsi anomala e disfunzionale, ma bensì un fenomeno psicofisico normale che “prepara” ed “attiva” la persona davanti ad una certa situazione che richiede specifiche reattività sia mentali, che fisiologiche.
L’ansia è dunque rilevabile dall’innalzamento della vigilanza e del funzionamento di sistemi fisiologici come ad esempio l’aumento del battito cardiaco, del respiro e/o del tono della muscolatura, i quali mettono l’organismo all’erta circa una possibile esigenza di reazione e/o prestazione.
La reazione ansiogena costituisce dunque una sorta di difesa intrinseca all’ancestrale istinto di conservazione (attacco-fuga), la quale cerca di avvertire ed attivare l’organismo prima che il pericolo possa arrecare un eventuale danno o prima di una specifica azione sempre cruciale.
L’ansia è, come accennato, un sistema di allerta funzionale alla persona, ma quando però essa stessa aumenta eccessivamente, si traduce in una surreale ed esagerata preoccupazione circa i propri pensieri, sentimenti, comportamenti, etc. e rispetto alla reale situazione in cui avviene.
I Disturbi d’ansia sono allora connotati da una eccessiva, continua e disfunzionale iperattivazione e ipervigilanza ansiosa circa gli eventi esterni e da senso di impotenza e indifesa da essi stessi.
In tal modo in certi casi la reazione emotiva di ansia non risulta adattiva e, anzi, aumentando di intensità e frequenza può appunto generare uno o più Disturbi d’Ansia, nei quali la persona non riesce più a capire e gestire i propri livelli emotivi e, di conseguenza, di affrontare cose anche normalmente semplici e di controllare i molteplici fattori di stress che la vita ci mette innanzi.
La risposta irrealistica e sproporzionata diviene allora un vero e proprio disturbo psichico con un quadro sintomatologico complesso ed articolato in sintomi sia mentali, che fisiologici.
In specifico i Disturbi d’Ansia porta a forte e permanente disagio psicologico con reazioni di fuga, evitamento, intensa paura, incapacità di fare cose semplici, così come a sintomi psicofisici destabilizzanti come spasmi, nausea, pallore, sudorazione, tachicardia, sensazione di soffocamento, vertigini, mal di testa, dolori, iper attivazione, tensione e rigidità muscolare, blocco motorio.
Ulteriori complicazioni di un Disturbo d’Ansia può essere il fatto che esso possa portare altri problematiche psicologiche e fisiche come patologie organiche, abuso e/odipendenza da alcol o da altre sostanze psicoattive (utilizzate per cercare di trovare sollievo dai numerosi sintomi d’ansia), disturbi dell’umore, problemi sessuali, problemi psicosomatici e/o sonno problematico.
Infine tali disturbi psicologici, se non affrontati, possono con il passare del tempo cronicizzare, con il pericolo di intensificarne i disagi e le disfunzionalità arrecate nelle varie aree vitali della persona e di renderne la possibile risoluzione sempre più difficile.
Nel contesto di molti Disturbi d’Ansia si manifestano Attacchi di Panico ed Agorafobia:
– Un Attacco di Panico corrisponde ad un periodo preciso durante il quale vi è l’insorgenza improvvisa di intensa apprensione, paura o terrore, spesso associati ad una sensazione di catastrofe imminente.
Durante questi attacchi sono presenti sintomi come palpitazioni, dolore o fastidio al petto, sensazione di asfissia o di soffocamento, e paura di impazzire o di perdere il controllo.
– L’Agorafobia è l’ansia o l’evitamento verso luoghi o situazioni dai quali sarebbe difficile (o imbarazzante) allontanarsi, o nei quali potrebbe non essere disponibile aiuto in caso di un Attacco di Panico o dell’improvviso arrivo di sintomi tipo panico.
DISTURBI PSICOSOMATICI O SOMATOFORMI
La caratteristica comune dei Disturbi Psicosomatici (o Somatoformi) è la presenza di sintomi fisici che fanno pensare ad una condizione medica generale, da qui il termine somatoforme, e che non sono invece giustificati da una condizione medica generale o dagli effetti diretti di una sostanza o da un altro disturbo mentale.
I sintomi devono causare significativo disagio o menomazione nel funzionamento personale, sociale, lavorativo, scolastico, familiare, affettivo o in altre aree vitali ancora. I sintomi fisici non sono intenzionali ovvero sotto il controllo della propria volontà.
I Disturbi Psicosomatici possono essere considerati delle vere malattie fisiologiche che possono provocare problemi e danni a livello organico, scatenate da personali e patologiche dinamiche psico-emotive dell’individuo.
I sintomi psicosomatici sono dunque il risultato di situazioni di forte stress, disagio,paura, ansia, etc. che attivano ed iper-attivano, come in un continuo stato di emergenza il sistema nervoso autonomo, che a sua volta reagisce con risposte vegetative che provocano disturbi a livello fisico.
A riprova di tutto ciò nei Disturbi Psicosomatici non vi è nessuna condizione medica generale diagnosticabile a cui possano essere pienamente attribuibili i sintomi fisici.
Generalmente i Disturbi Psicosomatici si manifestano a danno dell’apparato gastrointestinale (ad esempio: gastrite, colite, ulcera), dell’apparato cardiocircolatorio (ad esempio: tachicardia, aritmia, ipertensione), dell’apparato respiratorio (asma, iperventilazione), dell’apparato urogenitale (dolori mestruali, impotenza,eiaculazione precoce, anorgasmia, enuresi), della pelle (psoriasi, acne, la dermatite, prurito, orticaria, secchezza cutanea e delle mucose, sudorazione eccessiva), del sistema muscolore (cefalea, crampi, torcicollo, mialgia, artrite).
Infine i Disturbi Psicosomatici si possono associare da un Disturbo d’Ansia o da unDisturbo dell’Umore o scaturire proprio in seguito ad essi stessi.
DISTURBI SESSUALI
I Disturbi sessuali di natura psichica sono caratterizzati da una qualche dinamica psicologica personale e/o interpersonale (o anche di altro tipo), che interferisce negativamente su una o più parti della sfera sessuale dell’individuo.
Dunque nel caso si presenti un disturbo sessuale, e non vi siano sottostanti cause fisiologiche come ad esempio carenze ormonali, assunzione o abuso di farmaci, specifiche patologie fisiche, etc., le possibili cause alla sua base sono di tipo psicologico.
I Disturbi sessuali di natura psicologica sono in tal senso provocati da molteplici dinamiche psichiche e pragmatiche come:
- non conoscere l’anatomia e la fisiologia dei genitali, i tempi e le esigenze propri e del partner;
- ascoltare e seguire certe credenze e miti come l’avere per forza un orgasmo simultaneo e/o di una certa durata;
- conflitti e sensi di colpa interni che portano all’evitamento del piacere sessuale in tutte le sue forme;
- tensioni psicologiche verso il partner che portano ad evitare il più possibile i rapporti sessuali;
- intensa e persistente ansia e/o paura di avere un insuccesso in campo sessuale (ad esempio ansia da prestazione, paura di fallire, timore del rifiuto);
- eccessiva auto-percezione ed auto-osservazione delle proprie prestazioni sessuali e/o di quelle del partner, con incapacità ed impossibilità a rilassarsi e ed abbandonarsi al piacere sessuale;
- personali problematiche psicologiche di ansia, paura, stress, flessione dell’umore, fissazione, nervosismo, etc., che impediscono le normali dinamiche psicofisiche dell’atto sessuale (certe volte anche totalmente come nel caso dell’Anoressia sessuale);
- personali credenze ideologiche e religiose e/o personali schemi cognitivi e/o di atteggiamento disfunzionali (es. la fissazione di impostare e condurre il rapporto sessuale in un predeterminato modo, spazio e tempo, oppure la certezza di contrarre una qualche malattia dalle pratiche di tipo sessuale).
La reattività ed il funzionamento sessuale della persona è contraddistinto dalla cosidetta “Risposta sessuale“, ovvero da un ciclo costituito da quattro fasi distinte, ma unite tra loro e strettamente necessarie l’una per il verificarsi dell’altra successiva.
Tale risposta psicofisica è dunque suddivisa in:
- Fase del Desiderio;
- Fase dell’Eccitazione;
- Fase dell’Orgasmo;
- Fase della Risoluzione.
Le disfunzioni psicosessuali sembrerebbero imputabili proprio ad un cattivo funzionamento di una delle quattro fasi che costituiscono questo ciclo. In tal modo i Disturbi sessuali possono aver luogo in una o più di queste stesse fasi di risposta sessuale.
Le Fasi della risposta sessuale sono:
- La “Fase del Desiderio“; contraddistinta dalle fantasie e dai desideri circa l’attività sessuale. Questa fase ha inizio attraverso alcune stimolazioni della sfera sessuale di tipo fisico, ad esempio baci, carezze, etc., e di tipo psicologico, ad esempio il pensiero/desiderio di baciare, toccare, accarezzare il partner (o comunque qualcun’altro che attivi appunto il desiderio sessuale).
- La “Fase dell’Eccitazione” (o “Fase del Plateau”); caratterizzata dalle sensazioni di piacere sessuale e dal momento di massimo eccitamento psicofisico. In questa fase avvengono cruciali modificazioni fisiologiche a livello genitale come l’erezione del pene e la lubrificazione e la dilatazione della vagina. Vengono inoltre avvertite piacevoli sensazioni di calore, formicolio, ipersesibilità cutanea e distrazione e leggerezza psico-cognitiva ed emotiva.
- La “Fase dell’Orgasmo“; costituita dal picco più alto di piacere sessuale, ovvero del raggiungimento del massimo godimento psicofisiologico. Tale fase corrisponde nell’uomo all’eiaculazione e nella donna alle contrazioni ritmiche delle pareti vaginali e del clitoride. Inoltre in entrambi la pelle si arrossa, il battito cardiaco aumenta, il respiro diventa più frequente, i capezzoli e le dita di mani e piedi si irrigidiscono ed in generale il corpo viene percorso da gradevoli ed incontrollabili sussulti, mentre la mente da percezioni, sensazioni e pensieri piacevoli e di benessere.
- La “Fase della Risoluzione“; rappresentata da una sensazione di rilassamento muscolare e di benessere psicofisico generale.
Per passare al momento dell’eccitamento, ovvero alla seconda fase del ciclo sessuale, è indispensabile che il sistema neuropsicologico attribuisca un significato erotico ai suddetti pensieri, desideri e stimoli, inducendo appunto questa prima fase contraddistinta da desiderio sessualmente connotato.
Sia nell’uomo che nella donna i disturbi della fase del desiderio sono il desiderio ipoattivo ol’avversione sessuale.
Per passare alla fase dell’orgasmo, ovvero alla terza fase del ciclo sessuale, è fondamentale che la persona attraversi un momento eccitatorio appagante, sia a livello psicologico che fisico, e sufficientemente lungo ed articolato attraverso una giusta ed equilibrata stimolazione psicofisica (secondo la soggettività di ognuno), dunque ne troppo blanda, ne troppo brusca o maldestra.
Nell’uomo il disturbo più frequente della fase dell’eccitazione è il disturbo dell’erezione, mentre nella donna è la mancanza di eccitazione e di lubrificazione.
Nell’uomo il disturbo più comune della fase dell’orgasmo è l’eiaculazione precoce (esiste anche quella ritardata e quella impossibile o non piacevole), mentre nella donna è l’anaorgasmia o frigidità, ovvero l’impossibilità di raggiungere l’orgasmo.
Dopo quest’ultima fase vi è un momento detto “periodo refrattario” (o anche “fase di recupero”), durante il quale l’uomo non può raggiungere un ulteriore erezione; la durata di tale lasso di tempo varia da individuo ad individuo secondo fattori soggettivi e situazionali.
Sempre a livello sessuale e con cause psicologiche, vi sono poi i disturbi da dolore sessuale, ovvero la Dispareunia, che può colpire sia il sesso maschile che quello femminile e caratterizzata da un rapporto sessuale doloroso, ed il Vaginismo, cioè l’involontaria contrazione delle pareti vaginali che impedisce la normale penetrazione rendendo l’atto sessuale difficoltoso, doloroso e/o impossibile.
Infine nella sfera sessuale dell’individuo può verificarsi anche il cosidetto Disturbo dell’Identità di Genere, contraddistinto da una persistente e fortissima identificazione col sesso opposto e contemporaneamente da un intenso disagio psichico riguardante questa stessa pulsione interna, così come verso il proprio stesso sesso di appartenenza vissuto alquanto negativamente.
Vi sono poi le Parafilie, ovvero ulteriori problemi sessuali contraddistinti da un certo livello di gravità in quanto costituiti da forti e ricorrenti impulsi, fantasie e/o comportamenti appunto di tipo sessuale, i quali rendono necessario, per raggiungere una adeguata risposta sessuale, l’utilizzo di oggetti, attività o situazioni inusuali e/o pericolose o dannose per se stessi e/o altre persone.
DISTURBI DELL’ALIMENTAZIONE
I Disturbi dell’alimentazione sono connotati da problemi e patologie legate al cibo di natura psicologica.
Essi si caratterizzano da una serie di pericolose, dannose e grossolane alterazioni del comportamento alimentare, le quali possono avere conseguenze anche molto gravi a livello psicofisico.
Le cause di tali problematiche, come accennato, sono di tipo psichico, laddove intense tensioni, pensieri, paure, stress, ansie, sensazioni a livello interno si traducono in atteggiamenti alimentari disfunzionali.
I Disturbi alimentari sono uno dei problemi psicologici maggiormente in espansione negli ultimi decenni; è stato infatti rilevato che negli ultimi 40 anni l’incidenza dell’Anoressia è addirittura raddoppiata.
Tali Disturbi caratterizzano società economicamente avanzate, come quelle occidentali, nelle quali la forma fisica e l’apparenza hanno ormai purtroppo conquistato il primato sulla bellezza e sull’intelligenza interiore.
I mezzi di comunicazione, sempre più veloci e diretti, hanno aggravato tale dinamica sociale, contribuendo alla diffusione di modelli incentrati sulla magrezza.
I principali disturbi dell’alimentazione:
- L’Anoressia Nervosa: caratterizzata dal rifiuto di mantenere il peso corporeo al di sopra del peso minimo normale
- La Bulimia Nervosa: caratterizzata da ricorrenti episodi di abbuffate seguiti dall’adozione di mezzi inappropriati per controllare il peso, come il vomito autoindotto, l’uso di lassativi, diuretici o altri farmaci e/o il digiuno o l’attività fisica praticata in maniera eccessiva
- L’ Obesità: contraddistinta da un anormale ed eccessivo ingrassamento, così ingente mettere in serio pericolo ed oggetto di gravi danni la salute psico-fisica generale
- Il Binge Eating Disorder: caratterizzato da frequenti episodi di abbuffate compulsive, senza successive condotte compensatorie, come ad esempio vomito auto indotto o uso di diuretici e lassativi
- L’ Ortoressia: caratterizzata dall’ossessione psicologica per il mangiare sano
- La Night Eating Syndrome: caratterizzata da ripetute abbuffate, fino ad un terzo delle calorie giornaliere, nel periodo serale ed in quello notturno
- La Drunkoressia: caratterizzata dall’associazione di Anoressia e/o Bulimia e consumo eccessivo di alcool (alcune volte di Alcolismo).
♦ Caratteristica essenziale comune della Anoressia e della Bulimia Nervosa è la presenza di una alterata percezione del peso e della propria immagine corporea.
N.B. Recenti studi hanno posto in evidenza ulteriori condizioni di forti squilibri nell’alimentazione dell’individuo dovuti a cause psicologiche e fisiologiche. Essi non rientrano tra le pagine di specifici manuali di psicologia e/o medicina, ma meritano sempre più attenzione, vista la loro progressiva veloce diffusione degli ultimi anni e dei loro numerosi sintomi psico-fisici negativi e disfunzionali.
DISTURBI DEL SONNO
Il sonno è per ogni organismo, e quindi anche per l’essere umano, un momento fondamentale di benessere e di recupero delle energie.
Esso infatti stimola ed influenza molteplici processi di crescita e numerosi fattori cognitivi come ad esempio la fissazione in memoria degli avvenimenti e delle nozioni elaborate durante il giorno.
Il sonno è fondamentale per il riposo non solo fisiologico, ma anche e soprattutto per il recupero di quelle psico-cognitive. Durante tale cruciale momento infatti avvengono una serie di meccanismi a livello del sistema nervoso come ad esempio, ed in particolare, la codificazione dei dati acquisiti nella parte mnemonica durante la veglia e l’eliminazione di quelli in eccesso; una sorta di riassetto e ripulitura dei nostri circuiti e componenti cerebrali, laddove le informazioni utili ed utilizzate vengono mantenute, mentre quelle ridondanti e superflue vengono cancellate.
Tutto questo fa facilmente intuire l’indispensabile necessità di avere e mantenere un sonno neuropsicologicamente e fisicamente ristoratore.
Il campanello d’allarme che può ricondurre alla presenza di un Disturbo del sonno è la percezione da parte dell’individuo di un sonnoqualitativamente e/o quantitativamente insufficiente e/o insoddisfacente.
Dunque quando la persona non riesce ad avere beneficio dal riposo perché dorme troppo poco, eccessivamente, male, o con frequenti ed improvvisi risvegli o incubi, si può pensare alla presenza di un Disturbo del sonno.
Sembra che tali disturbi insorgano in seguito ad uno sfasamento dei meccanismi di generazione o di regolazione del ritmo sonno-veglia dovuto a fattori psicologici ed ambientali.
La quantità e la qualità del sonno necessarie all’individuo sono assai soggettive, e proprio per questo variano da persona a persona; inoltre esse possono cambiare secondo l’età e/o la presenza di fattori soggettivi come forti stati di preoccupazione, problemi socio-familiari o di fattori esterni, come ad esempio svolgere un lavoro stressante o di forte responsabilità oppure dormire in un luogo percepito come pericoloso o comunque inospitale.
Tali situazioni possono allora produrre stati psico-emotivi di ansia e/o stress e quindi ridurre sia la quantità che la qualità del sonno.
I principali disturbi del sonno:
- Le Dissonnie (Insonnia, Ipersonnia, Narcolessia): caratterizzate da anomalie della quantità, della qualità o del ritmo del sonno
- Le Parasonnie (Sonnambulismo, Disturbo da Incubi, Disturbo da Terrore nel Sonno, Sonniloquio (parlare nel sonno), Bruxismo (digrignare i denti durante il sonno), Sindrome delle gambe senza riposo (muovere involontariamente gli arti inferiori impedendo l’addormentamento o comunque un buon sonno) : caratterizzate da comportamenti anomali o da eventi fisiopatologici che si verificano durante il sonno, durante specifici stadi del sonno o nei passaggi sonno-veglia.
Consigli per un Buon Sonno
Come già detto avere un buon sonno è fondamentale; qui di seguito vi sono alcune regole per poter cercare di ottenere un suo miglioramento qualitativo e quantitativo:
- andare a dormire ed alzarsi allo stesso orario, sia nei giorni feriali, che nel week-end
- se durante la notte siamo riusciti a dormire poco e/o male, non cercare di recuperare il sonno dormendo di più la mattina
- allo stesso modo non cercare di fare sonnellini diurni
- se l’addormentamento non arriva, non rimanere a letto, ma piuttosto alzarsi e dedicarsi a qualcosa di rilassante per favorirlo
- per quanto detto cercare di rilassarsi prima di andare a letto e quindi non intraprendere comportamenti attivanti
- la sera cenare con alimenti leggeri, e non eccedere con le bevande alcoliche
- poco prima di andare a letto cercare di non consumare alcol, caffeina e/o tabacco
- coricarsi su un letto ed un cuscino confortevoli senza eccedere o diminuire troppo la copertura
- coricarsi in una stanza il più possibile isolata acusticamente da eventuali rumori e con una temperatura interna equilibrata (circa 21 gradi)
- fare attività fisica regolare.
DISTURBI PSICOTICI
In generale la Psicosi si riferisce alla manifestazione di deliri e/o di allucinazioni rilevanti di qualsiasi tipo, al linguaggio disarticolato e/o al comportamento disorganizzato, bizzarro o catatonico e al distacco dalle emozioni e dagli avvenimenti propri ed altrui.
In specifico la caratteristica comune dei Disturbi Psicotici è la presenza di un allontanamento psicopatologico dall’ambiente che circonda la persona, e di difficoltà a progettare ed iniziare delle attività e a provare sentimenti ed emozioni nei confronti degli altri individui.
Dunque i Disturbi Psicotici sono evidenziati da forti alterazioni dell’equilibrio psicologico dovute alla lontananza dalla realtà esterna e ad intensi disturbi del pensiero.
I Disturbi Psicotici hanno infatti come principale caratteristica la presenza di:
- Disturbi della forma del pensiero, ovvero alterazioni del flusso delle idee, fino alla loro incoerenza, e alterazione dei nessi associativi;
- Disturbi di contenuto del pensiero, ovvero deliri;
- Disturbi senso-percettivi, ovvero allucinazioni uditive, visive, olfattive, tattili, gustative.
Per quanto detto chi è afflitto da un Disturbo Psicotico non riesce più ad affrontare la vita sociale, affettiva, lavorativa, familiare a causa di pensieri fortemente disturbati, all’offuscamento dell’attenzione e della concentrazione, e all’affievolimento dell’iniziativa e del piacere di parlare e relazionarsi con gli altri e di fare e progettare attività in generale.
Solitamente i Disturbi Psicotici hanno inizio durante il periodo adolescenziale o nella prima età adulta e molto spesso sono il risultato di fattori psicologici, fisiologici e genetici, ma non sono ancora chiare le precise cause dietro all’insorgenza di tali disturbi.
Certi fattori psichici, come intenso e cronicostress, possono innescare o influenzare negativamente una personale predisposizione a sviluppare un Disturbo Psicotico.
I principali Disturbi Psicotici sono:
- La Schizofrenia: caratterizzata dalla progressiva complicazione, della durata di almeno sei mesi, di varie funzioni psico-cognitive, sociali ed emotive, come la comparsa (per non meno di un mese) di deliri, allucinazioni, eloquio e comportamento grossolanamente disorganizzati, appiattimento dell’emotività, isolamento, catatonia, e dalla patologizzazione dell’ambito sociale con la graduale estraneazione ed isolamento nei confronti dell’ambiente e degli stimoli circostanti.
- Il Disturbo Schizofreniforme: caratterizzato da una sintomatologia uguale a quella della Schizofrenia tranne che per la durata. Infatti esso ha una durata tra uno e sei mesi. Inoltre spesso non vi è menomazione o compromissione dell’ambito personale, sociale, affettivo, lavorativo tipiche della Schizofrenia.
- Il Disturbo Schizoaffettivo: caratterizzato dalla concomitante comparsa di un episodio di alterazione dell’umore e di sintomi positivi psicotici della Schizofrenia, il tutto preceduto o seguito da almeno due settimane di deliri o allucinazioni.
- Il Disturbo Delirante: caratterizzato da almeno un mese di deliri non bizzarri in assenza di altri sintomi positivi della Schizofrenia.
- Il Disturbo Psicotico breve: caratterizzato da almeno un giorno, ma entro un mese, di sintomi positivi psicotici della Schizofrenia, ovvero deliri, allucinazioni, eloquio disorganizzato e/o comportamento disorganizzato o catatonico.
- L’appagamento degli impulsi di tutti i Disturbi sopra brevemente descritti porta alla persona piacere, gratificazione, e/o alleviamento della tensione psicologica interna.
DISTURBI CORRELATI A SOSTANZE
I Disturbi Correlati a Sostanze comprendono problemi e disturbi derivanti dall’assunzione di una particolare sostanza come ad esempio Alcol, Cocaina, Eroina,Nicotina, Cannabis (es. Marijuana e Hashish),Allucinogeni (es. LSD e Ecstasy), Amfetamine(es Amfetamina e Metamfetamina), Inalanti,Farmaci e Psicofarmaci, Caffeina, Steroidi Anabolizzanti, Antidolorifici (o Antinfiammatori), Smart drugs, etc. I Disturbi Correlati a Sostanze si dividono in due gruppi: i Disturbi da Uso di Sostanze (ovvero Dipendenza da Sostanze e Abuso di Sostanze) e i Disturbi Indotti da Sostanze (ovvero Intossicazione da Sostanze, Astinenza da Sostanze, Delirium indotto da Sostanze, Demenza Persistente indotta da Sostanze, Disturbo Amnestico Persistente indotto da Sostanze, Disturbo Psicotico indotto da Sostanze, Disturbo dell’Umore indotto da Sostanze, Disturbo d’Ansia indotto da Sostanze, Disfunzione Sessuale indotta da Sostanze e Disturbo del Sonno indotto da Sostanze).
Le principali manifestazioni della Dipendenza da Sostanze (o Tossicodipendenza) rientrano in un quadro sintomatologico costituito da sintomi psico-cognitivi, fisiologici e comportamentali correlati all’uso ripetuto di una certa sostanza, che incidono patologicamente sulle varie sfere vitali dell’individuo.
Vi è la presenza allora di un uso reiterato e di una assunzione compulsiva della sostanza, nonostante tali problematiche, interne ed esterne, psichiche e fisiche, siano sempre più intense e croniche.
Vi è poi l’insorgenza di sintomi di “Craving“, ovvero l’intensa pulsione ed pensiero fisso verso il procurarsi ed usare la sostanza, di “Tolleranza“, cioè la necessità di assumere dosi progressivamente sempre più alte della stessa sostanza per avere gli effetti precedentemente ricevuti, ed infine di “Astinenza“, ovvero una serie di manifestazioni psico-fisiche dovute alla mancanza più o meno prolungata della sostanza.
Perchè vi sia Dipendenza da una certa sostanza occorre che ricorrano, lungo un periodo di almeno dodici mesi, almeno tre tra questi sintomi:
- Tolleranza (o Assuefazione)
(ovvero il bisogno di quantità sempre maggiori di sostanza per raggiungere l’effetto provato precedentemente con dosi minori ed intensamente ora desiderato; oppure l’effetto fortemente diminuito in corrispondenza all’uso continuato della medesima quantità di sostanza).
- Astinenza
(ovvero la modificazione psico-cognitiva, fisiologica e comportamentale concomitante all’assenza più o meno prolungata della sostanza instaurata dalla discesa della concentrazione dei suoi principi nel sangue, dalla conseguente mancanza di effetti sia mentali, che fisiologici e dall’assenza del contesto situazionale che accompagna prima, durante e dopo l’assunzione della sostanza.
I principali sintomi psico-fisici dell’astinenza sono ipotensione, tachicardia, tremori, crampi e dolori ai muscoli, vertigini, difficoltà visive e motorie, disturbi gastro-intestinali, sudorazione alterata, sonno e alimentazione disturbati, ansia, sensazione di morte imminente, sensazione di soffocamento, paranoie, pensieri ricorrenti, umore altalenante, comportamenti aggressivi, autolesionismo.
Dopo la sperimentazione di tali spiacevoli sintomi di astinenza, la persona tende a riassumere la sostanza proprio per attenuare o evitare tali sintomi, con il risultato però di aumentare le dosi in modo esponenziale e ancor più dannoso e pericoloso, entrando di fatto in un circolo sempre più stretto e privo di uscite.
- Assunzione continuativa ed eccessiva della sostanza e alcune volte in quantità maggiore e per un periodo più lungo di quanto pianificato e/o previsto (utilizzo compulsivo).
- Grande desiderio o presenza di numerosi sforzi di diminuire, controllare o interrompere l’uso.
- Forte dispendio di tempo, energie e denaro per cercare e poter avere la sostanza, per assumerla e per riprendersi dai suoi effetti.
- Riduzione e/o interruzione delle attività personali, ricreative, scolastiche, sociali, lavorative, familiari, etc.
- Continuo uso ed incapacità di interromperlo, nonostante la conoscenza della presenza del problema e delle sue gravi conseguenze psicologiche e fisiologiche.
- Intenso desiderio interno e pensieri fissi circa la ricerca e l’utilizzo della sostanza (Craving).
(P.S. Ne Tolleranza, ne Astinenza sono sufficienti e/o necessarie per diagnosticare una Dipendenza. Certi individui mostrano infatti tale disturbo psico-fisico in assenza di sintomi di Tolleranza e di Astinenza. Infatti in fase di diagnosi vi può essere la specificazione “con Dipendenza Fisica” o “senza Dipendenza Fisica” per indicare la presenza o meno di Tolleranza o Astinenza).
I problemi psico-cognitivi e comportamentali che possono scaturire dalla Dipendenza da Sostanze possono essere: discontrollo sui pensieri e sui comportamenti e ripetuti pensieri sulla sostanza e/o sulle modalità con le quali procurarsela, problemi di concentrazione, attenzione e memoria, intensa ansia, ossessioni e compulsioni,disturbi dell’umore, problemi del sonno,disturbi sessuali, impulsività ed aggressività, isolamento, senso di colpa, di vergogna e abbassamento dell’autostima.
Il processo che porta allo sviluppo di una Dipendenza è complesso ed articolato, visto che alla sua base vi sono molteplici fattori causali che si intersecano e si influenzano tra loro. Esso dunque è sospinto dalle proprietà psicoattive della sostanza stessa, ma anche dalle dinamiche situazionali nelle quali essa viene assunta e, non ultime, dalle caratteristiche personali, come ad esempio stress ed ansia interna, insicurezza, umore altalenante, disagi socio-familiari e/o lavorativi, difficoltà emotive ed affettive e così via. Ulteriori fattori possono essere lo status economico del consumatore ed il contesto sociale nel quale egli è inserito.
In generale il concetto di Dipendenza da sostanza (o Tossicodipendenza) si riferisce ad uno stile di vita quasi totalmente coinvolto e dedicato all’utilizzo compulsivo ed eccessivo di una certa sostanza o droga; tutto questo principalmente contraddistinto da marcati sintomi di Astinenza, Craving e Tolleranza, così come da infruttuosi sforzi di smettere il consumo e da forte menomazione nelle molteplici sfere vitali. Da qui addirittura la necessità di bloccare l’uso della sostanza con o senza il consenso e/o la comprensione del tossicodipendente per evitare conseguenze ancor più gravi.
Parlando invece dell’Abuso di Sostanze si può considerare sua caratteristica principale l’uso patologico di una sostanza contraddistinto da ricorrenti e significative conseguenze negative sulle varie sfere vitali della persona e correlate proprio all’uso ripetuto della sostanza stessa.
Perchè vi sia Abuso di una certa sostanza occorre che ricorrano, lungo un periodo di almeno dodici mesi, almeno una tra le seguenti situazioni:
- Ricorrente uso della sostanza con la conseguente incapacità di gestire i vari contesti lavorativo, familiare, personale, scolastico, sociale, etc. (ad esempio ritardi, assenze, sospensioni, litigi, scontri).
- Ricorrente uso della sostanza in situazioni potenzialmente rischiose (ad esempio guidando l’automobile).
- Ricorrenti problemi di tipo legale correlati all’uso della sostanza e ai suoi conseguenti effetti (ad esempio processi, arresto, detenzione).
- Uso continuativo della sostanza nonostante persistenti o ricorrenti problemi sociali o interpersonali causati o amplificati dall’uso della sostanza.
A differenza della Dipendenza da sostanze il possibile quadro sintomatologico dell’Abuso di sostanze non include Tolleranza, Astinenza e/o utilizzo compulsivo, mentre comprende le conseguenze dannose derivanti dal consumo ripetuto.
I più comuni sintomi psicopatologici associati all’uso di sostanze tossiche sono problemi dell’umore, ansia, sonno disturbato,allucinazioni, deliri e/o disturbi sessuali.
I principali disturbi correlati a sostanze:
I Disturbi da uso di Sostanze (Dipendenza ed Abuso di Sostanze):Dipendenza ed Abuso di Alcool (Alcolismo), Dipendenza ed Abuso di Cocaina, Dipendenza ed Abuso di Eroina, Dipendenza ed Abuso di Nicotina(Tabagismo), Dipendenza ed Abuso di Cannabis (es.Marijuana / Hashish), Dipendenza ed Abuso di Allucinogeni (es.LSD / Estasy), Dipendenza ed Abuso di Amfetamine (es.Amfetamina / Metamfetamina), Dipendenza ed Abuso di Inalanti (es.Solventi [Colla, Benzina] / Gas / Nitrati[Popper] / Anestetici), Dipendenza ed Abuso di Farmaci e Psicofarmaci (es. Ansiolitici / Sonniferi), Dipendenza ed Abuso di Caffeina (es. Caffè/ Energy Drink / Cola / Cioccolato), Dipendenza ed Abuso di Steroidi Anabolizzanti, Dipendenza ed Abuso di Antidolorifici (o Antinfiammatori), Dipendenza ed Abuso di Smart drugs (o Sostanze nootrope)
I Disturbi indotti da Sostanze: Intossicazione da Sostanze, Astinenza da Sostanze, Delirium indotto da Sostanze, Demenza Persistente indotta da Sostanze, Disturbo Amnestico Persistente indotto da Sostanze, Disturbo Psicotico indotto da Sostanze, Disturbo dell’Umore indotto da Sostanze, Disturbo d’Ansia indotto da Sostanze, Disfunzione Sessuale indotta da Sostanze, Disturbo del Sonno indotto da Sostanze
Recenti studi e moderne dinamiche personali, interpersonali e sociali hanno posto in evidenza negli ultimi anni ulteriori condizioni di abuso e di dipendenza con medesimi sintomi psico-fisici e legati a particolari situazioni e/o oggetti:
- La Dipendenza affettiva
- La Dipendenza dagli acquisti
- La Dipendenza dal fitness
- La Dipendenza dal gioco d’azzardo
- La Dipendenza dal gruppo
- La Dipendenza da internet
- La Dipendenza dal lavoro
- La Dipendenza dal mangiar sano
- La Dipendenza dalla pornografia
- La Dipendenza dal sesso
- La Dipendenza dal telefonino
- La Dipendenza dalla televisione
- La Dipendenza dai videogiochi
- La Dipendenza da Social Network
- La Dipendenza da Blackberry/IPhone
DISTURBI DEL CONTROLLO DEGLI IMPULSI
La caratteristica principale dei Disturbi del Controllo degli Impulsi è data dalla difficoltà della persona a resistere ad un un particolare impulso.
Una sorta di desiderio che essa non riesce a rimandare ed ancor meno a dissolvere; in tal modo la necessità è quella di appagare tale impulso nel minor tempo possibile.
Solitamente l’individuo afflitto da un Disturbo del controllo degli impulsi avverte un sentimento di progressiva tensione, agitazione ed eccitazione poco prima di mettere in atto l’impulso a livello comportamentale.
Nel momento successivo all’azione impulsiva egli sperimenta piacere, sollievo e/o gratificazione.
La perdita di controllo a favore di un improvviso ed incontrollabile impulso porta la persona verso la messa in atto di una azione potenzialmente dannosa per sé e per gli altri.
Infatti prima, durante e/o dopo tale azione possono comparire, con intensità e conseguente danno all’area sociale, familiare, lavorativa, affettiva, etc., ansia, flessione dell’umore, sensi di colpa, stress e rimorsi.
I principali disturbi del Controllo degli Impulsi sono:
- Il Disturbo Esplosivo Intermittente: aratterizzato dall’incapacità di controllare e di resistere agli impulsi aggressivi, tale perdita di controllo risulta avvenire saltuariamente.
- La Cleptomania: caratterizzata dalla persistente incapacità di controllare e di resistere all’impulso di rubare un qualsiasi oggetto, magari privo di valore o di utilità per la persona.
- La Piromania: caratterizzata dalla persistente incapacità di controllare e di resistere all’impulso di accendere e dare fuoco a qualcosa.
- Il Gioco d’Azzardo Patologico: caratterizzato dalla persistente incapacità di controllare e di resistere all’impulso di mettere in atto comportamenti di gioco d’azzardo.
- La Tricotillomania: caratterizzata dalla persistente incapacità di controllare e di resistere all’impulso di strapparsi dei capelli.
Recenti studi hanno posto in evidenza ulteriori condizioni di forti squilibri negli impulsi dell’individuo dovuti a cause psicologiche come:
- Il Disturbo da Shopping Compulsivo: caratterizzato dalla persistente incapacità di controllare e di resistere all’impulso di comprare oggetti, anche inutili o non indispensabili.
- Il Binge Eating Disorder: c aratterizzato da frequenti episodi di abbuffate compulsive, senza successive condotte compensatorie, come ad esempio vomito auto indotto o uso di diuretici e lassativi.
- Il Binge Drinking: caratterizzato da frequenti episodi di bevute compulsive di quantità alcoliche superiori alla personale tolleranza psicologica e fisiologica, con l’intento di provare ebbrezza e di arrivare alla ubriacatura.
L’appagamento degli impulsi di tutti i Disturbi sopra brevemente descritti porta alla persona piacere, gratificazione, e/o alleviamento della tensione psicologica interna.
DISTURBI DA STRESS O DELL’ADATTAMENTO
Lo Stress rappresenta una intensa risposta psicofisica da parte di tutto l’organismo di fronte a richieste, sia mentali che fisiologiche, soggettivamente eccessive(questo in quanto la risposta di Stress dipende dalla personale valutazione interna rispetto allo specifico stimolo-situazione).
Quando arriva lo Stress si ha allora uno stato di “esaurimento psicofisico” dovuto ad una situazione di cambiamento, che ha reso necessario un grande dispendio adattivo, sia a livello fisico che psicologico.
Per quanto accennato la dinamica di Stress è una reazione di adattamento dell’organismo a fattori di mutamento interno o esterno; essa inoltre può essere ”acuta”, nel caso in cui si verifichi in uno spazio temporale abbastanza limitato ed una sola volta, oppure “cronica”, cioè quando essa si manifesta lungo un arco di tempo lungo ed in modo continuo.
E’ bene però precisare che lo Stress può anche risultare utile e funzionale per superare certe difficoltà nel breve momento (in gergo questo tipo di Stress è conosciuto come “Stress buono” e in psicologia viene definito “Eustress”); esso però può ben presto divenire pericoloso e dannoso se eccessivamente prolungato nel tempo (in tal caso si definisce, sempre in modo gergale, “Stress cattivo” e secondo le teorie psicologiche “Distress”).
Dunque lo Stress non va sempre e comunque considerato negativamente ed evitato, ma bensì considerato, se breve e non intenso, come elemento vitale e funzionale al miglioramento adattivo in senso biologico, mentale e caratteriale. Nei casi invece in cui esso risulta essere pesante e prolungato, inducendo forte menomazione in molte dinamiche interne ed esterne della persona, allora diviene una seria patologia dalla quale possono poi derivare molteplici altri disturbi psicofisici.
L’essere umano possiede a livello connaturato la capacità di adattarsi alle situazioni avverse (sempre più spesso oggigiorno definite appunto “stressanti”), attraverso meccanismi psichici e fisiologici di reazione-azione che cercano di compensare e riequilibrare le normali e funzionali dinamiche biologiche e mentali.
Quando però i fattori di stress sono eccessivi e/o troppo prolungati la persona esaurisce le riserve di energia utili per le reazioni di adattamento, recupero e riequilibrio, finendo per incappare in una serie di problematiche sia psichiche, che fisiche e gradualmente in veri e propri disturbi aventi sintomi gravemente disfunzionali nelle varie sfere vitali dell’individuo.
In tal modo se lo Stress continua e si intensifica può comportare la comparsa di veri e propri Disturbi da Stress (o dell’Adattamento) contraddistinti da sintomi psicofisici negativi ed invalidanti per le molteplici aree fondamentali della vita della persona.
Si realizza così una sorta di processo stressogeno (definito anche come “Sindrome generale di adattamento”) nel quale le componenti psicologiche e fisiche attraversano tre fasi:
- allarme-attivazione;
- resistenza-adattamento;
- esaurimento-comparsa di problemi psicofisici.
I Disturbi da Stress (o dell’Adattamento) sono caratterizzati dallo sviluppo di sintomi psico-emotivi, comportamentali e fisici in risposta a specifici e ben identificabili fattori stressanti entro tre mesi dalla comparsa di questi ultimi.
Proprio come suggerisce il loro nome, in tali Disturbi la persona non riesce ad “adattarsi” ai fattori di stress, finendo per accusare problemi e disturbi psicofisici.
I disagi che comportano divengono sempre più intensi, disturbanti e compromettenti per le varie aree vitali dell’esistenza (es. sociale, lavorativa, familiare, affettiva, scolastica, etc.) e superano ben presto la normale e funzionale capacità di reazione allo stress insita in ogni individuo.
I Disturbi da Stress (o dell’Adattamento) vengono solitamente classificati sulla base della tipologia predominante di sintomi presente; in tal modo si possono distinguere:
- Disturbo da Stress (o dell’Adattamento) con umore depresso;
- Disturbo da Stress (o dell’Adattamento) con ansia;
- Disturbo da Stress (o dell’Adattamento) con ansia e umore depresso;
- Disturbo da Stress (o dell’Adattamento) con alterazione della condotta (dei comportamenti socialmente e moralmente normali);
- Disturbo da Stress (o dell’Adattamento) con alterazione dell’emotività e della condotta.
Solitamente eventi e/o periodi più o meno lunghi di Stress derivano da molteplici fattori (definiti anche “Agenti stressanti” o “Stressors”); ne sono degli esempi: ritmi sempre più frenetici, contraccolpi o cambiamenti repentini nelle aree vitali principali (sociale, familiare, scolastica, lavorativa, relazionale, personale, etc.) come ad esempio la morte di un caro, il pensionamento, il divorzio, la perdita del lavoro, la fine di una storia d’amore o d’amicizia.
Altri fattori di Stress possono essere:inquinamento, dinamiche ambientali o stagionali (es. innalzamento o abbassamento della temperatura, cambiamenti del clima o passaggi da stagione a stagione, etc.), sollecitazioni psicofisiche prima e durante intense attività fisiche e/o psicologiche, sport a livello agonistico, mutamenti storici, politici, sociali, etc. eclatanti, forti pressioni lavorative o scolastiche (es. in concomitanza di prove e resoconti, come infatti spesso succede ad alcuni studenti alla fine dell’anno di scuola o di fronte a verifiche e compiti, oppure a certi lavoratori davanti a mansioni specifiche e pesanti).
Possono risultare molto stressanti anche situazioni e cambiamenti positivi come ad esempio il matrimonio, la nascita di un figlio, una promozione, una novità felice, etc. e l’abuso di alcol, tabacco e/o ulteriori sostanze psicoattive.
Negli ultimi anni purtroppo la frequenza e l’intensità dei suddetti fattori stanno aumentando in esponenziale, con il risultato di rendere sempre più difficile o molte volte impossibile il naturale adattamento psicofisico dell’organismo, in corrispondenza di situazioni stressanti.
Nei Disturbi da Stress (o dell’Adattamento), a livello neurofisiologico, si assiste all’aumento o alla diminuzione-inibizione di certi ormoni (es. di certi Neurotrasmettitori come Dopamina, Noradrenalina o Serotonina) e di ulteriori sostanze cruciali per il buon funzionamento mentale e fisico ed il generale mantenimento della salute psichica ed organica.
In breve la Serotonina regola e media l’orologio interno, la temperatura, ed il funzionamento di molteplici sistemi organici, la Noradrenalina regola invece le trasmissione nervosa, i livelli di energia, il tono ed i meccanismi di ulteriori organi, infine la Dopamina è mediatrice di sostanze antidolore e responsabili del senso di piacere come ad esempio le Endorfine.
Quanto accennato fa ben capire quanto loStress eccessivo possa arrecare squilibri, problemi e patologie psicofisiche rappresentate da molteplici sintomi negativi e dannosi per il regolare funzionamento dei vari aspetti dell’esistenza della persona.
A livello fisiologico i Disturbi da Stress (o dell’Adattamento) provocano infatti anche affaticamento, rallentamento dei processi fisici, indebolimento, iperproduzione di ormoni androgeni (con aumento di problemi dermici e dei suoi annessi, come unghie o capelli), malfunzionamento tiroideo, ipersudorazione, inappetenza o iperfagia, battito cardiaco irregolare, sbalzi pressori, respiro corto, tosse, ulcera, acidità di stomaco (colite), stipsi, diarrea, dolori gastrointestinali, digestione difficile, crampi, contratture, blocchi, tensioni muscolari, cefalea.
A livello mentale i Disturbi da stress (o dell’Adattamento) inducono invece senso di stanchezza, spossatezza ed ottundimento, difficoltà cognitive e rallentamento delle prestazioni neuropsichiche, depressione oumore altalenante, sonno disturbato, ansia,attacchi di panico, nervosimo, problemi sessuali (es. calo del desiderio, orgasmo problematico, eiaculazione precoce, etc.), irritabilità e aggressività, sintomi psicosomatici, tachicardia, vertigini,comportamenti alimentari compulsivi, agitazione, senso di tensione e di infelicità diffuse.
I Disturbi da Stress (o dell’Adattamento) possono inoltre comportare, nelle situazioni più gravi e croniche, abuso di alcol e/o altre sostanze psicoattive, idee e tentativi di suicidio, complicazioni anche serie di eventuali patologie fisiche preesistenti al loro esordio.
Esistono numerose sostanze naturali che riescono ad aumentare la reattività di adattamento e ad agevolare il recupero psicofisico in caso di problemi di Stress, e definite appunto “Adattogeni” o “Sostanze adattogene”, ovvero in grado di agevolare l’adattamento dell’organismo davanti a dinamiche stressanti attraverso l’azione di specifici principi attivi in esse contenuti.
Tali sostanze riescono allora a ridare energia e vitalità psicocognitive e fisiologiche e a distendere le tensioni; ne sono un esempio l’Eleuterococco, il Ginseng, il Ginkgo Biloba, la Pappa Reale, la Rodiola, etc.
Lo Stress può essere contrastato, ridotto e dissolto anche con una giusta ed equilibrata dieta ricca di specifiche sostanze nutritive utili a ristabilire certi livelli psicofisici (es. Sali minerali, Vitamine, Aminoacidi, Bioflavonoidi,Omega 3, etc.), tecniche di rilassamento, attività fisica regolare, ma non intensa, ed unsupporto professionale di tipo psicologico.
I Disturbi da Stress (o dell’Adattamento) possono comportare l’esordio di ulteriori disturbi psicologici come:
Disturbi d’Ansia, Disturbi Psicosomatici, Disturbi dell’Umore, Disturbi sessuali, Disturbi dell’Alimentazione, Disturbi del Sonno, Disturbi correlati a Sostanze
DISTURBI DI PERSONALITÀ
La Personalità è il soggettivo e costante gruppo di modalità (o gruppo di tratti) con il quale la persona si rapporta, percepisce, vede e pensa nei confronti di se stessa e dell’ambiente circostante.
Ogni persona presenta allora la sua specifica Personalità costituita da un insieme di tratti o “sfaccettature” uniche, specifiche e stabili, con le quali si definisce verso se stessa e verso gli altri, e attraverso cui si rapporta sia con il personale mondo interno, che con quello esterno (emozioni, cognizioni, relazioni, atteggiamenti, etc.).
Tali modi o tratti di Personalità si manifestano e sono importanti in molteplici occasioni e contesti, modellandosi ed adattandosi alle dinamiche e alle situazioni più diverse di ogni giorno; inoltre specificano e delineano l’individuo, proprio come le altre sue personali caratteristiche psicofisiche, rappresentando un suo ulteriore fattore distintivo.
Quando però questi tratti si rivelano sempre più rigidi e disadattivi a certe normali situazioni e verso la propria stessa persona, causano incisivi disagi e disfunzionalità in varie aree vitali, formando, di fatto, una vera e propria patologia interna, definita Disturbo di Personalità.
Un Disturbo di Personalità è rappresentato, in sintesi, da certe aspettative e modelli interiori e di atteggiamento fortemente dissociati e disfunzionali rispetto alla realtà esterna specifica della persona e nei confronti delle norme generali. Esso si presenta solitamente durante l’adolescenza o la prima età adulta e si mostra pervasivo ed inflessibile nel tempo.
Chi è afflitto da un Disturbo di Personalità può presentare grandi difficoltà nel riconoscere, interpretare e/o controllare le emozioni, le cognizioni e/o i comportamenti e a capire e modulare le dinamiche interne altrui, spesso vi possono anche essere percezioni distorte sul proprio sé e sulle altre persone, così come l’incapacità di controllare i propri impulsi con conseguenti manifestazioni estreme di ansia, rabbia, depressione, paura, etc.
Nei casi più gravi di Disturbi di Personalità la persona può arrivare a manifestazioni comportamentali violente e distruttive, abuso di sostanze psicoattive (es. Alcol, Cocaina,Metamfetamina, etc.), tentativi di suicidio, atteggiamenti di autolesionismo.
Spesso in tali Disturbi vi sono ulteriori caratteristiche dovute all’inflessibilità della Personalità dell’individuo rispetto a se stesso e al contesto. Si evidenziano allora stili di pensiero e di comportamento rigidi, continui ed immutabili che si palesano ad esempio nell’incapacità a tollerare differenze e difetti personali e/o altrui, atteggiamenti strani, non gestibilità dei problemi e delle frustrazioni, difficoltà di accettazione, di empatia e di rapporto verso gli altri, scarso adattamento ambientale, non utilizzo di esperienze pregresse, etc.
I Disturbi di Personalità sono raccolti in tre gruppi (A, B, C), sulla base di alcune loro caratteristiche analoghe:
- Gruppo A / Disturbi caratterizzati da comportamento bizzarro
Sono contraddistinti da modalità strane, insolite, eccentriche o paranoiche e dalla tendenza alla diffidenza e all’isolamento.
- Disturbo di Personalità Paranoide: caratterizzato da sfiducia e sospettosità; per questo le motivazioni e i comportamenti degli altri vengono tendenzialmente interpretati come malevoli o minacciosi. La persona viene così percepita come ostinata, polemica, non dialogica.
- Disturbo di Personalità Schizoide: caratterizzato da una espressione emotiva ristretta, dal distacco dalle dinamiche relazionali e dal non desiderio di instaurarle e/o mantenerle; in tal modo vi è mancanza di relazioni e vita molto riservata ed isolata. La persona viene allora percepita come appartata o isolata.
- Disturbo di Personalità Schizotipico: caratterizzato da intenso disagio nelle relazioni, emotività inappropriata, atteggiamenti insoliti, distorsioni percettive o cognitive (presenza di credenze magiche e/o bizzarre), isolamento sociale, eccentricità; vi è dunque scarso contatto con la realtà.
- Gruppo B / Disturbi caratterizzati da alta emotività
Sono contraddistinti da modalità emotive, teatrali, instabili, estreme, imprevedibili e dalla mancanza di empatia.
- Disturbo di Personalità Antisociale: caratterizzato da una continua inosservanza e violazione delle leggi e dei diritti altrui, così come dalla mancanza di sensi di colpa circa gli atti criminosi commessi.
- Disturbo di Personalità Borderline: caratterizzato da forte instabilità delle relazioni, dell’immagine del proprio Sé e delle dinamiche affettive; è presente inoltre impulsività ed instabilità dell’umore e forte oscillazione tra poli opposti in molte altre aree funzionali della vita. (Da non confondere con il Disturbo bipolare o la Ciclotimia).
- Disturbo di Personalità Istrionico: caratterizzato da eccessiva emotività e seduttività, manifestazioni emotive teatrali, continua ricerca di attenzione degli altri, eloquio e comportamenti iperattivati.
- Disturbo di Personalità Narcisistico: caratterizzato da senso di grandiosità ed unicità, necessità di continua ammirazione ed attenzione, ipersuscettibilità alle critiche, mancanza di empatia e di intelligenza emotiva (riconoscere e capire le dinamiche interne altrui).
- Gruppo C / Disturbi caratterizzati da forte ansietà
Sono contraddistinti da modalità ansiose e/o paurose e da una considerevole inibizione e scarsa autostima.
- Disturbo di Personalità Evitante: caratterizzato da assoluto evitamento delle dinamiche e delle situazioni socialmente connotate, senso di inadeguatezza, ipersensibilità e intollerabilità verso i giudizi negativi degli altri, forte inibizione e timidezza. (Da non confondere con la Fobia sociale, con la quale però condivide certe caratteristiche)
- Disturbo di Personalità Dipendente: caratterizzato da eccessivo bisogno di essere accuditi, atteggiamento sottomesso, delega di tutte le personali decisioni, mancanza di autostima, paura dell’abbandono.
- Disturbo di Personalità Ossessivo-Compulsivo: caratterizzato da una forte tendenza al perfezionismo, intensa preoccupazione per l’ordine e la precisione, ipercontrollo delle dinamiche interne, degli avvenimenti e degli impegni, marcata rigidità nei pensieri e negli atteggiamenti. (Da non confondere con ilDisturbo ossessivo-compulsivo).
(Occorre precisare che la suddetta divisione non esclude la possibilità che nello stesso individuo si presentino Disturbi di Personalità anche appartenenti a gruppi diversi).
Perché si possa creare un vero e proprio Disturbo di Personalità, i tratti personologici devono rendere disfunzionali almeno due sfere vitali dell’individuo, tra quella emotiva, cognitiva, interpersonale e personale, in modo stabile, costante e pervasivo, ed infine determinare significativo disagio e compromissione del normale funzionamento lavorativo, scolastico, sociale, relazionale, etc.
Dunque un Disturbo di Personalità è dato da una serie di modalità rigide, disfunzionali, costanti e stabili nel tempo, di pensare, sentire, e comportarsi; una sorta di variante inflessibile e non adattiva dei tratti di personalità normali.
Tale quadro sintomatologico, per costituire veramente un Disturbo di Personalità, non deve essere provocato da specifici problemi e disturbi psicologici o dagli effetti dovuti all’assunzione, dipendenza e/o abuso di farmaci, psicofarmaci o ulteriori sostanze psicoattive o ancora da particolari condizioni fisiche patologiche (es. traumi cranici, malattie del sistema nervoso, etc.).
Altra distinzione per poter individuare con certezza la presenza o meno di un Disturbo di Personalità va fatta tra questi ultimi ed eventuali sintomi somiglianti, ma in realtà dovuti a risposte psicofisiche disfunzionali di fronte a situazioni stressanti, ansiogene, deprimenti, etc. (ovvero a Disturbi da Stress,Disturbi d’Ansia, Disturbi dell’umore, etc.).
E’ bene infatti specificare che i Disturbi di Personalità non sono caratterizzati da specifici sintomi come nel caso dei Disturbi Psicologici, ma piuttosto dalla presenza di tratti personologici rigidi e patologizzanti.
Solitamente l’esordio di un Disturbo di Personalità, come accennato, si instaura durante il periodo adolescenziale o leggermente più tardi nella prima età adulta (e per esser tale deve risultare persistente, pervasivo e non dovuto ad una particolare fase di sviluppo o ad un peculiare disturbo psicologico).
Le caratteristiche negative dei Disturbi di Personalità possono non essere considerate un problema dalla persona (in tal caso si parla di “egosintonia” o di “tratti egosintonici”) e in questi casi le varie problematiche possono rimanere latenti e in qualche modo gestite, provocando comunque disagio e disfunzionalità in molteplici aree esistenziali.
In questi casi le dinamiche di personalità patologiche possono comunque esser messe in evidenza ed esacerbate, con la conseguente necessità e richiesta di aiuto e supporto psichico, da eventi stressanti e traumatici e/o dall’esordio e progressione di uno o più Disturbi psicologici.
I tratti di personalità disfunzionali diventano consueti e ripetuti, tanto che la persona può non rendersi conto di risultare rigida ed inadeguata; inoltre essi possono alimentare reazioni negative degli individui vicini, le quali, a loro volta, confermano la giustezza delle modalità personologiche messe in atto, creando di fatto un circolo sempre più chiuso e problematico.
Certe persone nel tempo possono comunque accorgersi della situazione e se motivate a migliorare, con l’aiuto di uno specialista, possono gradualmente limare e smussare certi “spigoli” di personalità, a tutto beneficio del recupero di salute e benessere psicofisico generale e/o di eventuali altri problemi o disturbi concomitanti.